Il pedante in cucina- Julian Barnes
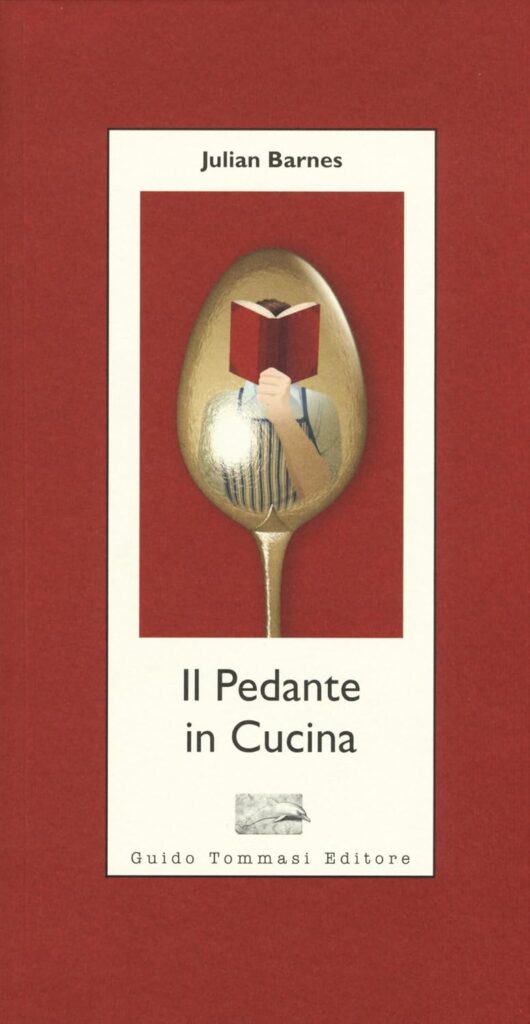
SINTESI DEL LIBRO:
Sono un cuoco tardivo. Durante la mia infanzia, la convenzionale
pruderie borghese proteggeva ogni azione si svolgesse nella cabina
elettorale, nel letto di due coniugi e nel confessionale. Mi era
sfuggito un quarto luogo segreto – segreto, quanto meno, per i
maschi – nella casa della classe media inglese: la cucina. Da lí, i
pasti e mia madre facevano la loro comparsa – pasti spesso
assicurati dai prodotti dell’orto di mio padre – anche se sul processo
che li portava a compimento né lui, né mio fratello, né io
sollevavamo domande o eravamo incoraggiati a farlo. Nessuno
arrivò mai a dire che cucinare fosse un’attività da femminucce;
semplicemente non si addiceva agli uomini di casa. Nei giorni di
scuola, mio padre preparava la colazione – porridge riscaldato con
melassa, pancetta e pane tostato – mentre i figli si dedicavano alla
pulizia delle scarpe e alla manutenzione della stufa: raccogliere la
cenere, ricaricarla di carbone.
Ma le competenze culinarie maschili si limitavano chiaramente a
quelle incombenze mattutine. Se ne ebbe la dimostrazione quella
volta che mia madre si dovette assentare. Mio padre mi preparò il
pranzo al sacco e, non avendo ben compreso i rudimenti teorici della
preparazione di un panino, lo imbottí amorevolmente con ingredienti
supplementari di cui sapeva quanto fossi ghiotto. Qualche ora dopo,
a bordo di un treno della Southern Region diretto a un campo
sportivo fuori città, aprii il sacchetto del pranzo davanti ai miei
compagni di rugby. I miei panini trasudavano, cadevano a pezzi, ed
erano di un rosso brillante per via della barbabietola paternamente
tagliata; arrossivano per me come io arrossivo per il loro artefice.
E per la cucina andò come per il sesso, la politica e la religione:
quando cominciai a scoprirne qualcosa da solo, era troppo tardi per
fare domande ai miei genitori. Non erano riusciti a insegnarmi allora,
e io li avrei puniti non chiedendogli nulla adesso. Avevo all’incirca
venticinque anni e studiavo legge; alcuni intrugli che escogitavo
all’epoca erano un vero reato. Il mio piatto forte era la braciola di
maiale con piselli e patate. I piselli erano surgelati, ovviamente; le
patate in scatola, già pelate, sguazzavano in un succo dolciastro che
bevevo con gusto; le braciole di pancetta erano ben lontane da
qualunque altra cosa in cui mi sarei imbattuto in seguito con quel
nome. Disossate, tagliate in serie e di un rosa brillante, si
distinguevano per la qualità di conservare un colore molto acceso
indipendentemente dal loro tempo di cottura. Il che offriva ampia
libertà d’azione allo chef: non si potevano definire poco cotte a meno
che non fossero decisamente fredde, né troppo cotte a meno che
non fossero carbonizzate e in fiamme. Poi una colata di burro finiva
per affogare i piselli, le patate e, di solito, anche le braciole di
pancetta.
I fattori chiave che regolavano la mia «cucina» di allora erano la
povertà, l’incompetenza e il conservatorismo gastronomico. Altri
forse avrebbero potuto vivere di frattaglie; io al massimo mi spingevo
alla lingua in scatola, anche se il manzo sotto sale conteneva
indubbiamente parti della bestia che non avrei gradito nella loro
forma originale. Un alimento base era il petto d’agnello: semplice da
fare arrosto, piuttosto facile individuarne la giusta cottura, grande
abbastanza da garantire tre cene consecutive al costo di uno
scellino circa. Poi fui promosso alla spalla d’agnello. La servivo con
un’enorme torta di porri, carote e patate che preparavo affidandomi a
una ricetta dell’«Evening Standard» di Londra. La salsa al formaggio
della torta aveva sempre un distinto sapore di farina, che peraltro si
attenuava un po’ alla volta riscaldandola giorno dopo giorno. Solo in
seguito ne scoprii il motivo.
Il mio repertorio si fece via via piú ampio. Tra gli ingredienti che,
non dico avrei dovuto dominare, ma almeno in qualche modo
sottomettere, venivano innanzitutto la carne e le verdure. Poi si
aggiunsero i dolci e l’occasionale zuppa; piú tardi – molto piú tardi – i
gratin, la pasta, il risotto e i soufflé. Il pesce rappresentò sempre un
problema, in parte ancora irrisolto.
Durante le mie visite a casa, venne fuori che cucinavo. Mio padre
assistette a questa evoluzione con la stessa diffidenza, lieve e
condiscendente, che aveva già dimostrato quando fui sorpreso a
leggere il Manifesto del Partito Comunista o quando l’avevo costretto
ad ascoltare i quartetti d’archi di Bartók. «Se questo è il peggio che
possa accadere, – pareva suggerire quel suo atteggiamento, – direi
che posso farmene una ragione». Mia madre mostrò piú entusiasmo:
in mancanza di figlie femmine, c’era almeno un figlio che, a
posteriori, apprezzava i suoi anni trascorsi in cambusa. Non ci
mettemmo certo a scambiarci ricette, ma nemmeno le sfuggí la
bramosia dello sguardo con cui ora adocchiavo la sua antica copia
del Mrs Beeton. Mio fratello, accampando la scusa della vita
universitaria e del matrimonio, superò la cinquantina prima di
cucinare qualcosa di piú elaborato di un uovo fritto.
Conseguenza di tutto ciò – e mi ostino ad addossare la colpa al
«tutto ciò» piuttosto che a me stesso – è che, sebbene ora cucini
con piacere ed entusiasmo, lo faccio con scarso senso di libertà o
immaginazione. Ho bisogno di una precisa lista della spesa e di un
libro di cucina che mi faccia da tutore. L’ideale di una spesa senza
affanni – volteggiare con un cesto di vimini appeso al braccio
acquistando con tutta calma quel che di meglio offre il mercato, per
poi escogitare il modo di trasformarlo in qualcosa che Dio solo sa se
sia mai stato sperimentato prima – sarà sempre al di sopra delle mie
possibilità.
In cucina sono un pedante apprensivo. Mi attengo a temperature
e tempi di cottura. Mi fido degli strumenti piú che di me stesso. Mi è
difficile immaginare di tastare un pezzo di carne con l’indice per
sapere se è cotto. L’unica libertà che mi riservo con una ricetta è
abbondare sulla quantità di un ingrediente che trovo particolarmente
azzeccato. Che questo non sia un criterio a prova di errore trovò
conferma in quell’epica porcheria che preparai, una volta, con lo
sgombro, il Martini e il pangrattato: gli ospiti erano piú ubriachi che
sazi.
Per di piú, al momento di assaggiare mi dimostro riluttante e con
una scusa sempre pronta. Facciamo un esempio: è escluso che ora,
di pomeriggio, con il dolce gusto di tè che mi si attarda ancora in
bocca, il cibo abbia lo stesso sapore che avrà e che dovrebbe avere
questa sera, dopo un confortante gin tonic. Il che significa: temo di
scoprire quanto sappia poco di cibo, il cibo, in questa fase. Un’altra
scappatoia valida è convincersi che assaggiare sia del tutto inutile,
dal momento che si sta seguendo la ricetta alla lettera e visto che (a)
la ricetta non richiede che si assaggi a questo punto, e (b) è di fonte
autorevole e stimata: potrebbero mai i risultati essere diversi da
quelli previsti?
Lo ammetto, tutto ciò tradisce una certa immaturità. Cosí come i
miei puerili attacchi di volubilità da pseudochef. Se vi capitasse di
trovarvi nella mia cucina e, ficcato con nonchalance il dito in
qualcosa in via di preparazione, mi diceste che è buono, ci resterei
male perché avrei tanto tenuto a stupirvi portandovelo in tavola. E
se, al contrario, suggeriste con educazione, generosità e tatto che
manca giusto un pizzico di noce moscata, o che la salsa potrebbe
andare se solo la riducessi ancora, la considererei la piú sfacciata
delle intromissioni.
Non di rado riverso la mia ira anche sui libri di cucina su cui faccio
tanto affidamento. Eppure, questo è un ambito in cui la pedanteria è
comprensibile oltre che importante, e un cuoco domestico,
autodidatta e ansioso, che pare voler incenerire la pagina a furia di
fissarla, è probabilmente il massimo della pedanteria. D’altro canto,
perché un libro di cucina dovrebbe essere meno preciso di un
manuale di chirurgia? (Dando per scontato, non senza una certa
apprensione, che i manuali di chirurgia siano in effetti precisi.
Chissà, forse alcuni assomigliano addirittura a libri di cucina:
«Iniettate un goccio di anestetico nel tubo; tagliate e asportate un
tocco di paziente; osservate zampillare il sangue; fatevi una birra
con i colleghi; ricucite la cavità…») Perché la parola di una ricetta
dovrebbe essere meno importante della parola di un romanzo? La
prima può causare indigestione fisica, la seconda mentale.
A volte vorrei che le cose fossero andate diversamente, desiderio
di molti cuochi tardivi. Se solo mia madre mi avesse insegnato l’abc
della cucina tanti anni fa… A parte tutto il resto, almeno oggi non
sarei cosí patetico nel mio costante bisogno di approvazione. Non
appena la porta si chiude alle spalle dell’ultimo ospite, sento la solita
litania affiorarmi alle labbra: «Ho cotto troppo l’agnello / il manzo /
qualunque cosa fosse». Il che significa: «Non l’ho cotto troppo, vero?
E se l’ho cotto troppo, non è cosí importante, giusto?» Per lo piú
ottengo la tanto agognata smentita; raramente la tacita conferma
della regola della casa per cui, superati i venticinque anni, non si può
piú incolpare di niente i propri genitori. Anzi, si è persino autorizzati a
perdonarli. Perciò, ok, papà, quei panini alla barbabietola… sai, non
erano niente male, piuttosto saporiti, e, be’, decisamente originali. Io
stesso non avrei saputo fare di meglio.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :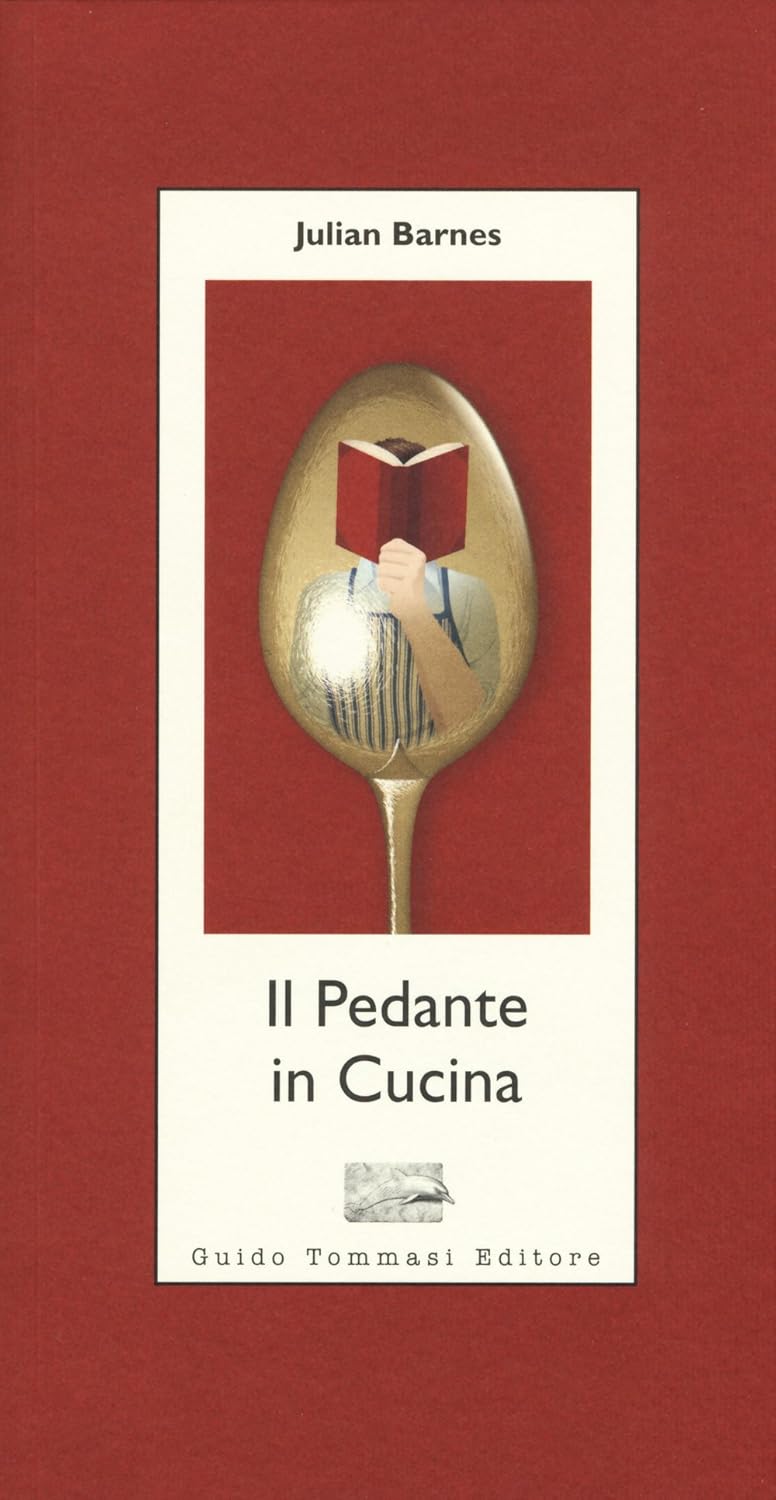






Commento all'articolo