Forma e imitazione – Come le idee si fanno mondo – Francesco Valagussa
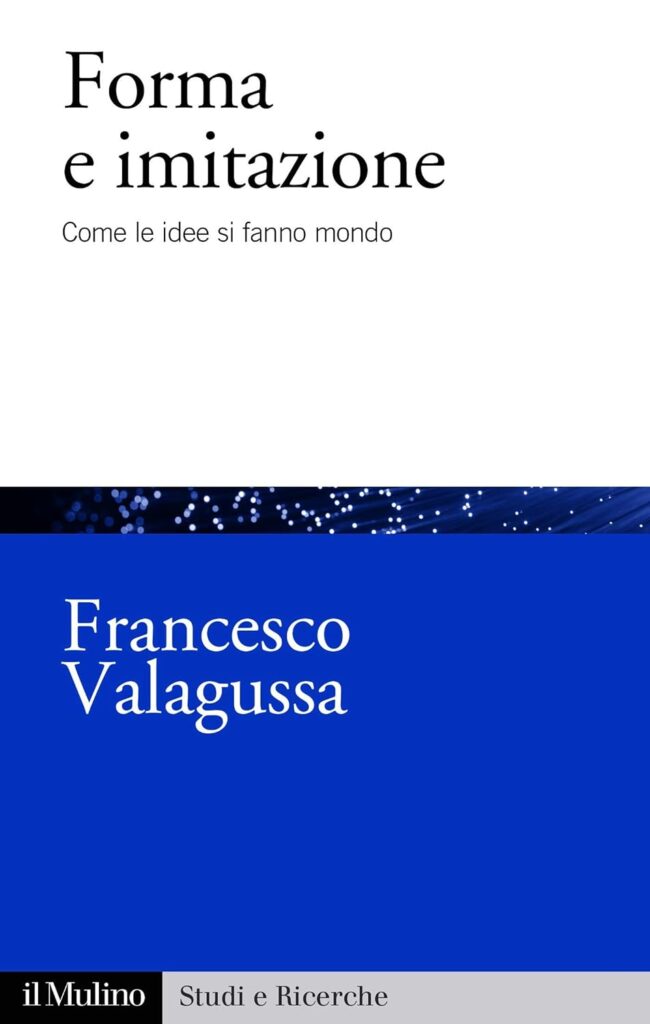
SINTESI DEL LIBRO:
Da un lato Anassagora sembra affermare la diversità di
anima e intelletto, e dall’altro si serve di entrambi come di
un’unica natura, salvo porre soprattutto l’intelletto come
principio di tutto»
[2]
. Nel paradosso individuato da Aristotele
compare la svolta fondamentale che contraddistingue la
teologia dei primi pensatori greci
[3]
: da un lato troviamo
l’anima, la forza di muoversi, la vita
[4]
; dall’altro lato
l’intelletto, la speculazione
[5]
.
«La ψυχή gradualmente trascorre da semplice vita, o anima
vitale, quale era in Omero ed Esiodo, a entità concepita e
definita come coinvolta nella percezione, nel pensiero, nella
sensazione»
[6]
, ma lo Stagirita avverte la problematicità di una
simile trasformazione: «qualora l’intelletto sia semplice e
impassibile, e non abbia nulla in comune con alcunché, come
afferma Anassagora, in che modo penserà, se il pensare è una
specie di subire?»[7]
.
Abbiamo due linee, due elementi, movimento e speculazione,
che finiranno per amalgamarsi: come appare assurdo che
l’intelletto – nella sua semplicità e separatezza – possa essere
principio di movimento
[8]
, così sembra inconcepibile che
l’anima – pura forza vitale – entri in rapporto col pensiero.
Attorno allo “snodo anassagoreo” lavorerà Platone e l’intero
pensiero occidentale
[9]
.
2. Separatezza e movimento
a) L’intelletto è separato, ma secondo Anassagora proprio
attraverso il movimento «l’intelletto operò il processo di
distinzione»
[10]
. Senza un rapporto con l’anima, l’intelletto
non potrebbe avere accesso al movimento, né innescare la
conoscenza: rimarrebbe nella sua morta separatezza.
b) L’anima dapprima è pura forza vitale, il movimento che
trascorre attraverso tutte le cose: non solo è incapace di
generare e mantenere qualcosa di separato, ma addirittura
osteggia la separatezza da cui sorge ogni ἐπιστήμη, sia che la si
intenda come lo come lo «stare sopra a qualcosa»
[11]
, sia che
la si concepisca come il «far fronte a qualcosa»
[12]
.
Dalla separatezza non si genera movimento, né il
movimento può generare separatezza. In nessun caso si
giungerebbe, per esempio, al “centauro aristotelico”
[13]
, «un
intelletto che desidera o un desiderio che ragiona»
[14]
: di per
sé «il pensiero non muove nulla»
[15] e il desiderio è
irrazionale
[16]
. L’Occidente è ricco di simili mostri. L’Uno
plotiniano è separato, infatti «ha generato l’atto senza prima
agire»
[17]
; l’immaginazione kantiana è sia spontanea che
recettiva
[18]
.
3. L’avvento delle forme
Iniziamo dalla separatezza: il mito celebra la scoperta delle
forme narrando la vittoria dell’Olimpo sulle divinità ctonie
[19]
.
Nell’ambiente che ci circonda indeterminato – così vorremmo
tradurre l’ἄπειρον περιέχον[20] di Anassimandro – irrompono le
forme e offrono un’occasione, un principio d’ordine.
Platone formulerà lo stesso dilemma nel Filebo: «L’insieme
delle cose e questo cosiddetto tutto, Protarco, dobbiamo dire
che è dominato dalla forza dell’irrazionale e dal come-capita
(τὸ ὅπῃ ἔτυχεν), o al contrario è governato da un’intelligenza e
da una meravigliosa saggezza ordinatrice?»[21]
.
Cercando di “addomesticare” l’indeterminato, Senofane
riduce a unità gli infiniti mondi anassagorei
[22]
: l’intuizione
del fondamento unitario dell’universo[23]
, per dirla con Jaeger,
«contiene però enigmi ancora più grandi di quelli che essa
risolve»
[24]
. Sempre intento a «ripulire l’idea del suo Dio unico
da tutte le scorie antropomorfe»
[25]
, scrive che il divino «senza
fatica tutto scuote con la forza del pensiero (νόου)»
[26]
, e non
scrollando la testa, o aggrottando le nere sopracciglia, come lo
Zeus di Omero
[27]
.
4. La pesante scissione
Non a torto considerato da Kurt von Fritz
[28] un precursore
di Anassagora, Senofane trasforma la concezione del divino:
«non è vero che fin dal principio gli dei hanno svelato tutto ai
mortali, ma col tempo essi cercando trovano il meglio»
[29]
. I
primi barlumi delle forme hanno già intaccato l’unità
originaria della phýsis-arché e «separato come realtà a sé
l’anima, che fino allora aveva fatto tutt’uno con la physis»
[30]
:
ora invece va cercando il meglio, sollecitata dall’intelletto.
Prima vi era la natura, vita che sorgeva da sé e si alimentava
in se stessa: l’anima vi prendeva parte, pienamente integrata
nel ciclo vitale. Adesso invece la separatezza delle forme
compromette la forza vitale onniavvolgente: le forme sono
divine, separate dai mortali; il divino non entra nel ciclo, e
dunque non muore più
[31]
.
La specularità dell’intelletto non è soltanto unità, ma è
separatezza che sconvolge il movimento vitale della natura
[32]
e la lingua greca ne reca traccia: il campo semantico del
vocabolo psiche si arricchisce, sino alla «perfetta unità di
anima vitale e coscienza»
[33]
. Che cosa può aver sollecitato la
trasformazione se non l’insorgenza delle forme[34]? Cosa, se
non quella «pesante scissione fra psiche e phýsis che due
millenni non sono riusciti a saldare»
[35]?
5. Eraclito e Parmenide
«Su questo sfondo s’intendono Eraclito e Parmenide: il
primo, per ricostruire l’unità della phýsis, nega le forme e
dialettizza gli opposti; il secondo, con lo sguardo fisso
sull’identità indialettizzabile della forma, relega ogni
opposizione nella sfera dell’apparenza e proclama la verità
invincibile dell’essere».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :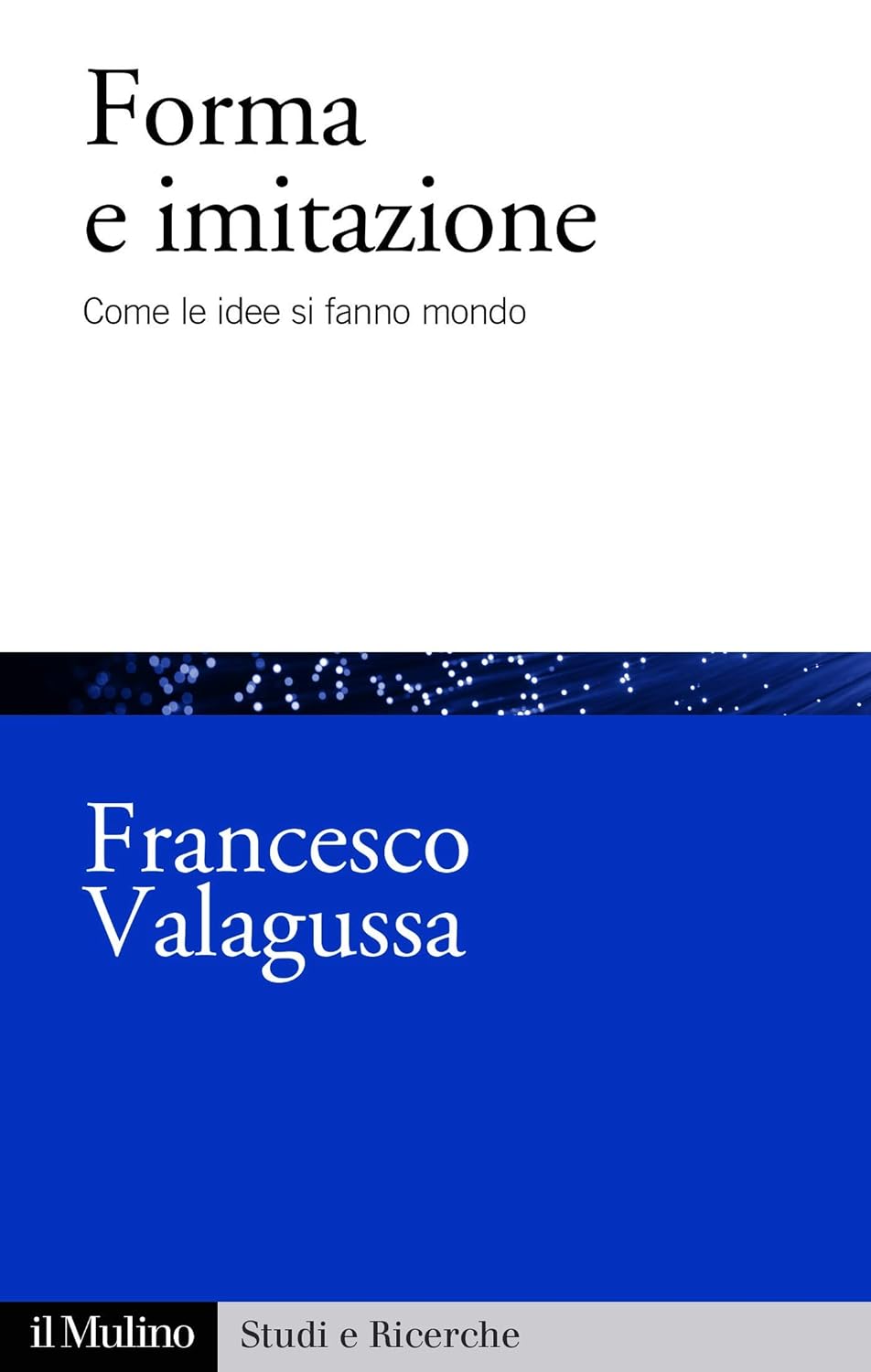






Commento all'articolo