Virus sovrano?: L’asfissia capitalistica – Donatella Di Cesare
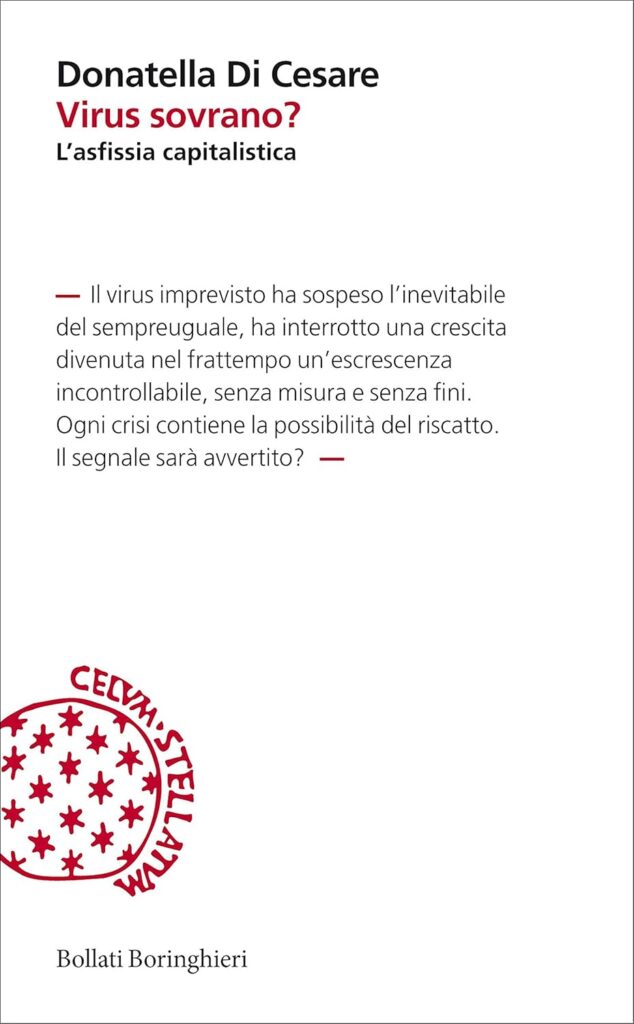
SINTESI DEL LIBRO:
Era già nell’aria da tempo. Molti hanno proseguito la vita
ignorandolo, per incredulità, sospetto, o solo per rassegnazione. Poi
tutto si è fermato – come si arresta un meccanismo usurato, che ha
girato troppe volte su se stesso. È sceso un silenzio spettrale,
squarciato dai sibili acuti delle sirene.
Malgrado i colori solari, che in primavera tingono le strade, tutto è
pervaso da uno stupore tetro. Sono scomparsi i tavolini dei bar,
dileguate le voci degli studenti. Sull’asfalto ovattato corrono veloci
autobus semivuoti, tracce del mondo febbrile di prima, note
discordanti.
Ognuno scruta il prossimo, da una finestra all’altra. Sul
marciapiedi due conoscenti si vanno incontro con impeto spontaneo,
ma il saluto si muta in un cenno amaro che dissuade l’altro, che
chiede distanza.
La città eterna, dopo secoli di storia, trattiene il fiato. In un’apnea
allibita, un’attesa angosciata.
È un evento epocale, che segna un prima e un poi, che ha già
cambiato il ventunesimo secolo, e perfino il modo di vederlo. Tra
disorientamento e sconcerto molti ripetono che è «senza
precedenti». Ed è giusto chiamare così la pandemia globale
scatenata dal coronavirus. Un evento – si sa – non è mai un unicum,
già solo perché si inserisce nella trama della storia. Tuttavia in
questo caso i paragoni con le vicende del passato, anche recente,
sono poco intonati, stridenti. Il Novecento sembra d’un tratto essersi
allontanato, come mai prima. Ecco perché rischia di prendere
abbagli chi usa lenti novecentesche per decifrare quel che sta
accadendo.
Come non considerare allora uno shock più vicino, quello dell’11
settembre? Il confronto è già stato accennato. Con il crollo delle Torri
Gemelle, un atto terroristico seguito in diretta da tutto il mondo, si è
inaugurato, nel 2001, il terzo millennio. Eppure le differenze sono
palesi. Sebbene fosse il primo avvenimento globale, per molti fu un
dramma sconvolgente, visto però da lontano, filtrato dallo schermo
televisivo. Vennero sollevate domande etiche sul «dolore degli altri»,
su quelle immagini non di rado spettacolarizzate, mentre a lungo
furono tema di dibattito le questioni politiche suscitate dalla «guerra
al terrore» e dall’incipiente stato d’emergenza. Quel crollo non scalfì
però davvero l’andamento della storia, il susseguirsi di decenni, dal
dopoguerra a oggi, dominati ancora dalla fiducia nel progresso,
votati al benessere crescente.
Invisibile, impalpabile, etereo, quasi astratto, il coronavirus
aggredisce i nostri corpi. Non siamo più solo spettatori – siamo
vittime. Nessuno si salva. L’attacco è sferrato nell’aria.
Subdolamente il virus mira al fiato, toglie il respiro e provoca una
morte orribile. È il virus dell’asfissia.
Il male che viene è un biovirus assassino, un germe catastrofico.
Ma questa volta non è una metafora. Ad ammalarsi è il corpo fisico –
il corpo logorato dell’umanità, l’organismo nervoso, affaticato,
sottoposto da anni a una tensione intollerabile, a un’agitazione
estrema. Fino all’apnea. Non è forse un caso che il virus proliferi
nelle vie respiratorie, dove passa l’alito della vita. Il corpo si sottrae
al ritmo accelerato, non regge più, cede, si ferma.
È il paventato incidente del futuro? Ogni diagnosi sarebbe
sbrigativa. Si è spinti tuttavia a credere che non sia un infortunio, un
contrattempo, un episodio periferico, ma che si tratti piuttosto di un
evento fatale che irrompe nel cuore del sistema. Non è solo una
crisi, bensì una catastrofe al rallentatore. Il virus ha fermato il
dispositivo. Quello che si vede è una convulsione planetaria, lo
spasmo prodotto dalla virulenza febbricitante, l’accelerazione fine a
se stessa, che ha inesorabilmente raggiunto il punto d’inerzia. È una
tetanizzazione del mondo.
Tutto sembra arrestarsi in una contrazione amara, una reazione a
catena, un effetto virale. È un’avaria imprevista (eppure già da
tempo prevedibile!), un guasto interno. L’ingranaggio gira a vuoto. Si
avverte quasi la dissonanza dei ferri che non si accordano più.
Come è impossibile decifrare l’ordine segreto delle catastrofi, così è
difficile dire che cosa porti con sé questa sospensione enigmatica.
Che il biovirus sia un ultimo, drammatico segnale d’allarme? Che
venga ancora messa alla prova la nostra resistenza vitale prima del
definitivo collasso?
Quel che il coronavirus ha scatenato non è una rivoluzione, come
qualcuno immagina, bensì un’involuzione. Il che non vuol dire,
tuttavia, che questa sosta improvvisa non possa essere pausa di
riflessione, intervallo prima di un nuovo inizio. Ciò che appare con
chiarezza è l’irreversibilità.
Non si può nascondere il desiderio di cambiamento che, negli
ultimi anni, è andato aumentando a causa di un sistema economico
ingiusto, perverso e obsoleto, i cui effetti sono fame e ineguaglianza
sociale, guerra e terrore, collasso climatico del pianeta, esaurimento
delle risorse. Adesso, però, a sconvolgere il mondo è un virus. Non
l’evento che si attendeva – quello che, nella bufera incessante, tra le
macerie del progresso, avrebbe tirato il freno d’emergenza della
storia.
Il virus imprevisto ha sospeso l’inevitabile del sempreuguale, ha
interrotto una crescita divenuta nel frattempo un’escrescenza
incontrollabile, senza misura e senza fini. Ogni crisi contiene sempre
la possibilità del riscatto. Il segnale sarà avvertito? La violenta
pandemia sarà anche la chance per cambiare? Il coronavirus ha
sottratto i corpi all’ingranaggio dell’economia. Tremendamente
mortifero, è però anche vitale. Per la prima volta la crisi è extrasistemica; ma non è detto che il capitale non saprà trarne profitto. Se
nulla sarà come prima, tutto potrebbe precipitare nell’irreparabile. Il
freno è tirato – il resto tocca a noi.
Tra calcoli e pronostici. Sulla «fine del mondo»
A quanto pare l’epidemia non era poi così imprevedibile. Era
stata, anzi, più volte annunciata negli ultimi cinque anni. Non parlo
né di scenari della fiction né di visioni escatologiche. Già nel 2017
l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) aveva avvertito che la
pandemia era imminente, una questione di tempo; non si trattava di
un’ipotesi astratta. Nel settembre 2019 un team del Global
Preparedness Monitoring Board, formato da esperti della Banca
Mondiale e dell’OMS, ha scritto in un rapporto: «la minaccia di una
pandemia globale è reale. Un patogeno in rapido movimento ha il
potenziale di uccidere decine di milioni di persone, devastare le
economie e destabilizzare la sicurezza nazionale».
Come mai quest’allarme è caduto nel vuoto? La questione
riguarda la scienza, prima ancora della politica. Il sospetto è che il
capitalismo accademico non giovi alla ricerca. Si offrono
conoscenze, si forniscono indicazioni, si delineano prospettive, ma
tutte le indagini restano nelle biblioteche governative, negli armadi
dei ministeri. La fatica degli scienziati finisce per ridursi alla vana
produzione letteraria.
Anche i risultati scientifici accolti all’esterno rischiano di essere
privi di efficacia per la mancanza di collaborazione. Esiste un trattato
internazionale stipulato nel 2005, sotto l’egida dell’OMS, che in
questo periodo è stato disatteso. Nonostante i ripetuti moniti, ogni
Stato ha seguito ostinatamente la propria politica, spesso confusa e
raffazzonata, lasciando credere che il virus fosse un problema degli
altri e giungendo – come Trump o Bolsonaro – a negare fino
all’ultimo il pericolo.
Si può dire che l’epidemia globale scatenata dal covid19 sia il
terzo grande evento del ventunesimo secolo. Dopo l’attacco
terroristico dell’11 settembre non si può infatti dimenticare la grave
crisi finanziaria e creditizia del 2008 che, scoppiata per una bolla
immobiliare, ha provocato negli anni, attraverso meccanismi di
contagio, una recessione globale e un indebitamento smisurato.
Molte sono le somiglianze tra la crisi finanziaria e quella sanitaria.
Anche la finanza ha i suoi virus. Ma al di là delle metafore, il covid19
viene dal corpo e dall’esterno ferma l’ingranaggio capitalistico. I
nessi, però, tra quella congiuntura e questa, sono stringenti. Una
crisi rinvia all’altra e, anzi, l’annuncia e la prepara, in una sorta di
ininterrotta catena catastrofica.
L’alba del terzo millennio è caratterizzata da un’enorme difficoltà
di immaginare il futuro. Si teme il peggio. Non c’è più attesa, né
apertura all’avvenire. Il futuro appare chiuso, destinato nel migliore
delle ipotesi a riprodurre il passato, reiterandolo in un presente che
ha le sembianze di un futuro anteriore.
Non per caso si moltiplicano a ritmo esasperato sondaggi,
congetture, previsioni. Va scorta qui la volontà di dominare il «futuro
peggiore», di controllarlo con il calcolo. È questo il sigillo e il
contrassegno della nostra epoca, dove il tempo che viene è la
minaccia che incombe nel cielo inquinato. Prevale un’attesa colma di
angoscia, carica di apprensione.
La «fine», tremenda e imperscrutabile, ha agitato nei secoli il
mondo. Ma questa fine ha oggi un significato reale. Non si tratta più
solo di «fine della storia», quella macabra profezia neoliberista che
negli ultimi decenni ha ripetuto there is no alternative!, non c’è
alternativa alla spietata economia del capitale.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :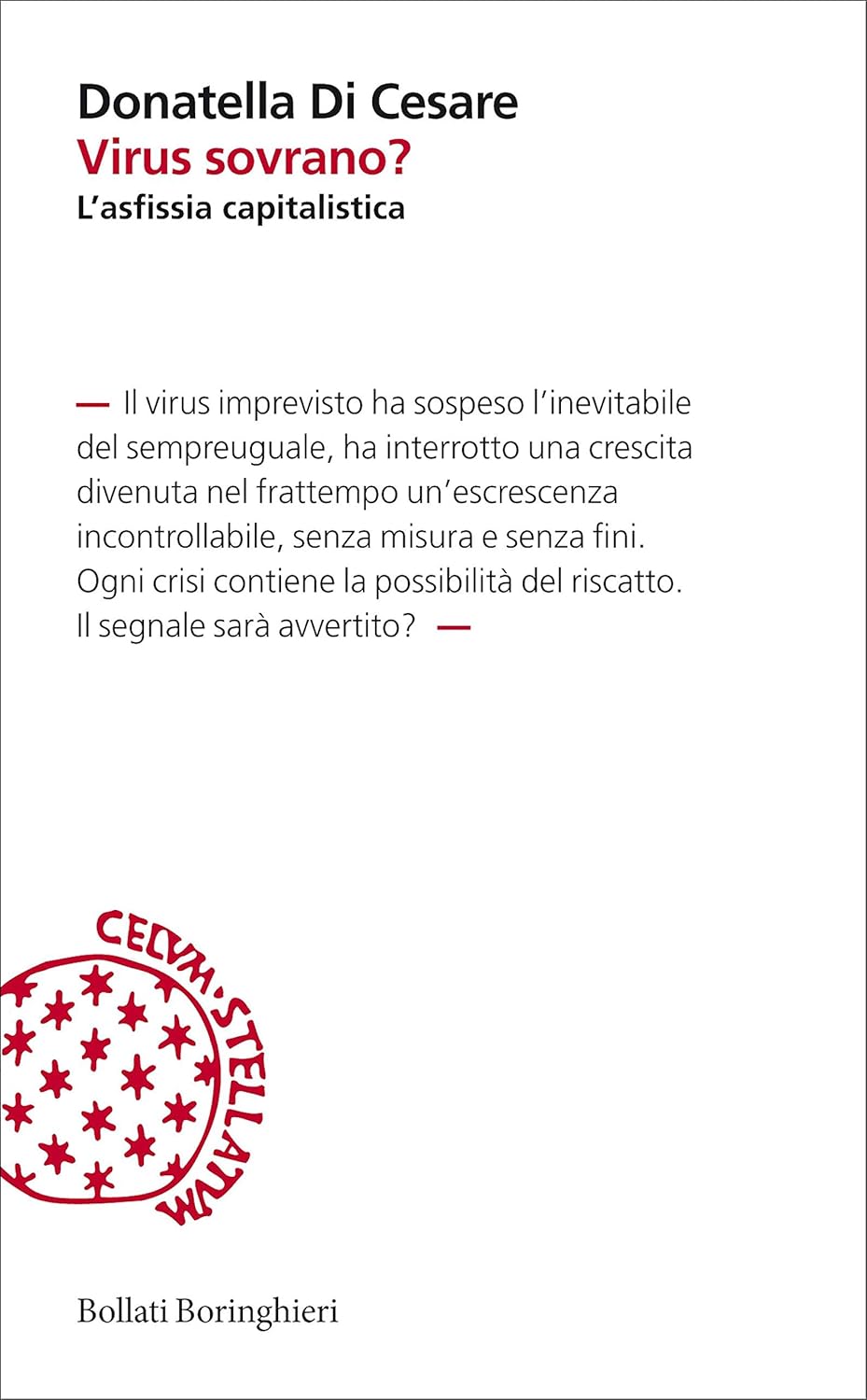






Commento all'articolo