L’arte della gioia – Goliarda Sapienza
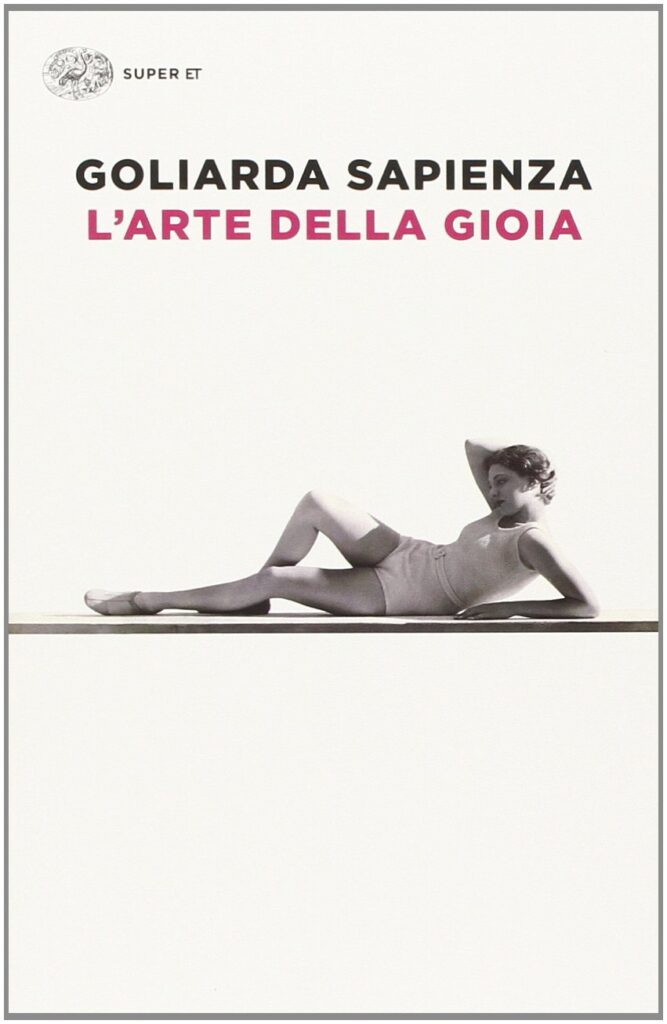
SINTESI DEL LIBRO:
Se è vero che ogni libro ha un destino, in quello dell’ Arte della gioia
c’entro di sicuro anch’io, fin dall’incontro con Goliarda nel
1975, fin dal lavoro di revisione del romanzo che Goliarda mi affidò
interamente. La sua morte improvvisa nel 1996 poi
m’avviluppò definitivamente in quel destino. Ormai era affidata a me
soltanto la responsabilità di far vivere o di abbandonare alla
distruzione la storia di Modesta, già completa dal remoto 1976. Piú
volte rifiutata a suo tempo dai principali editori, giaceva da
vent’anni in una cassapanca del mio studio in attesa di tempi piú
fortunati. Quei tempi non vennero mai. Finché Goliarda morí.
Pubblicai allora a mie spese L’arte della gioia in un migliaio
d’esemplari per i tipi di Stampa Alternativa. Era il 1998. Numerosi
critici e scrittori lo ricevettero. Passò sotto silenzio. Ricordo che
entravo tutti i giorni in una libreria Feltrinelli che teneva due copie
del romanzo dietro altri libri su una scansia in alto nascosta da una
colonna. Mi dicevo tutte le volte: ma chi dovrebbe comprarlo.
Un giorno notai che mancava una copia. Non so che avrei dato per
sapere l’identità di quell’unico compratore. Dopo qualche
tempo sparí anche l’altra. Era stupefacente.
Passarono tre anni senza che accadesse nulla di piú. Poi, grazie
all’appassionato interessamento di Loredana Rotondo,
dirigente di Rai Tre, fu dedicato alla figura di Goliarda un programma
nella serie Vuoti di memoria, dal titolo Goliarda Sapienza,
l’arte di una vita. Lavoro malinconico ma suggestivo, ricco
d’evocazioni, con numerose testimonianze fra cui la mia. Fu
mandato
in onda, caso raro, piú di una volta, anche se in orari come al solito
impossibili.
Non fu vano. Serví a destare l’interesse degli onnipotenti distributori,
sensibili ai supporti mediatici, i quali caldeggiarono alle
edizioni Stampa Alternativa una ristampa piú sostanziosa, che vide
la luce nel 2003. Questa volta cominciò a farsi strada un certo
interesse, piú di costume che propriamente letterario, com’è sempre
stato nel destino critico dell’opera di Goliarda.
Fuori dall’Italia, all’ Arte della gioia toccò una fortuna decisamente
migliore. Fin dall’edizione del 1998 avevo affidato il
romanzo a una giovane agente letteraria che s’occupava dei paesi di
lingua tedesca. A Francoforte suscitò l’interesse di
Waltraud Schwarze, geniale scopritrice di testi sconosciuti. Il
romanzo esce cosí a Berlino per Aufbau-Verlag. Esce la prima
parte: in Germania viene diviso in due parti. Ma Waltraud Schwarze
aveva intanto telefonato a Parigi a Viviane Hamy, allieva di
Robert Laffont, editrice nota per il suo coraggio, consigliandole di
leggere un romanzo paru en Italie en 1998 dans une petite
maison d’édition que personne ne connaît. Le texte est un peu
bizarre, il fait 600 pages. Il va coûter une fortune en traduction, il y
a peu de chance pour qu’il y ait plus de personnes qui le lise à
l’étranger qu’en Italie, mais c’est vraiment merveilleux.
Hamy allora fa immediatamente inviare il romanzo a una sua
traduttrice, Nathalie Castagné, anch’essa romanziera, che
cinque giorni piú tardi la chiama eccitata e insieme angosciata.
L’eccitazione risultando dalla lettura del libro, l’angoscia dal
timore che Viviane Hamy da una parte rinunciasse a tradurre il
romanzo, dall’altra, se avesse accettato, di divenire responsabile
della... rovina della casa editrice.
Il trionfo dell’ Arte della gioia in Francia comincia cosí, dalla
convergenza, libera da invidia e accidia, di tre donne
straordinarie. I critici hanno fatto il resto, e lo hanno fatto bene. A me
non resta, da scrittore italiano, che riscontrare dalla lettura
dell’immensa rassegna-stampa un interessante fenomeno: in
Francia i critici leggono i libri che recensiscono, magari quando gli
sembrano buoni, ma allora li leggono interamente.
Oggi L’arte della gioia è tradotto in numerosi paesi del mondo.
Quando nella primavera del 1996 balenò la possibilità di pubblicare
per intero il suo libro, Goliarda, accingendosi a rivedere
L’arte della gioia dopo vent’anni da quando l’aveva portato a termine,
pose davanti a sé una sorta di cartello con le seguenti
parole: «Sono passati trent’anni dal primo appunto su Modesta.
Attenta, Goliarda, a non cadere nel tranello dell’autocensura».
Temeva che due decenni di rifiuti editoriali, e tre di convivenza con la
protagonista del suo romanzo, potessero averle intaccato
la forza dell’idea originaria, e di scivolare nel peccato di autocensura,
la caduta piú grave per una scrittrice come lei. Temeva la
vergogna del tradimento piú stolto, quello della propria storia.
Chiunque al suo posto avrebbe avuto ragione di dubitare. I due
maggiori critici italiani avevano espresso giudizi del genere, il
primo: «È un cumulo di iniquità. Finché io sarò vivo non permetterò
la pubblicazione di un libro simile». Il secondo, spirito piú
elegante e libero, e piuttosto intimo di Goliarda, una volta aveva
risposto al telefono un po’ alterato: «Ma che c’ho a che fare io
con questa roba?!»
L’arte della gioia dev’essere un romanzo maledetto: per causa sua
Goliarda si ridusse in assoluta povertà, e andò persino in
galera. Aveva cominciato a scriverlo l’anno successivo a quel primo
appunto, cioè nel 1967. Aveva già portato a termine Lettera
aperta, che uscirà proprio in quell’anno, e Il filo di mezzogiorno, che
vedrà la luce due anni dopo. Sono i primi due romanzi di un
ciclo autobiografico di cinque, che Goliarda interruppe per nove anni
letteralmente posseduta dal bisogno di dar vita alla sua
protagonista, Modesta (quanta ironia nel nome!).
Scriveva di solito la mattina cominciando intorno alle nove e mezza,
e andava avanti sino all’una e trenta, le due, tutti i giorni,
cercando di sfuggire – e non era facile – ai numerosi inviti a
colazione nel sole di Roma di quegl’anni beati e agitati. Diceva
sempre che scrivere significa rubare il tempo anche alla felicità. Si
riposava canonicamente le domeniche. Fumava molto, come
un po’ tutti allora. La giornata di lavoro si concludeva spesso con un
bagno caldo. Nel tardo pomeriggio suonava alla porta una
assai piú giovane amica, Pilú, quasi rossa con delicate efelidi sul
viso e grandi occhiali. Insieme fumavano e bevevano; ma,
soprattutto, Goliarda le rileggeva quanto aveva scritto la mattina. La
regolarità dell’ascolto di Pilú credo sia stata determinante per
il progresso di un’opera che non è certo un raccontino come tanti
che si qualificano romanzi da un po’ di anni in qua. Pilú
ascoltava con attenzione non professionale ma da accanita e colta
lettrice. D’altra parte Goliarda qualche volta faceva leggere
quanto scriveva anche a Peppino, l’amato, distinto e sensibile
portiere della casa di via Denza.
Goliarda e Pilú andavano avanti cosí fino a sera. Dopo di che
Goliarda cucinava una rapida cena. Era uno straordinario
talento di cuoca. Riusciva a cucinare di tutto, con tutto, e soprattutto
senza farsene accorgere. Teneva molto che questo suo
talento le venisse riconosciuto. Dicessero pure che era una
mediocre scrittrice, ma non cattiva cuoca. Pare avesse ereditato
l’arte
dalla madre, Maria Giudice, che fra una rivolta contadina, uno
sciopero, un comizio e uno stuolo di figli, non disdegnava di
preparare ricchi pranzetti apprezzati – durante il comune esilio in
Svizzera – anche da un Mussolini ancora rivoluzionario e
nullatenente.
Ma spesse volte Goliarda e Pilú si univano a un gruppo di amici che
abitavano nella vicina via Paolo Frisi, e finivano lí la
serata fra ricche bevute dopo essere stati tutti insieme a cena fuori.
L’indomani mattina, dopo l’immancabile caffè nero a stomaco
vuoto dei siciliani, Goliarda risaliva al piano di sopra, in alto fra cielo
e nuvole – una curiosa mansarda ricavata da uno stenditoio,
con un’immensa vetrata sul mare dei pini sognanti di Villa Glori –, si
sedeva su una bassa poltroncina barocca, si poneva sui
ginocchi come scrittoio una custodia di cartone vuota, che aveva
contenuto vecchi dischi a 33 giri (le Fantasie di Bach eseguite,
credo, da Gieseking), e riprendeva a scrivere circondata da una
distesa di appunti tutti disseminati sul parquet.
Scriveva sempre su comuni fogli di carta extrastrong piegati in due
perché, diceva, questo formato ridotto le consentiva una
sua idea di misura – io credo però che fosse un ricordo, un bisogno
delle dimensioni del vecchio quaderno dell’infanzia – dove
vergava le parole con una grafia abbastanza minuta, facendo
ciascun rigo via via piú rientrato sino a ridurlo a una o due parole,
allora ricominciava daccapo con un rigo intero. Veniva fuori un
curioso disegno, una specie di elettrocardiogramma di parole, sí,
una scrittura molto cardiaca.
Goliarda scriveva sempre a mano, diceva che aveva bisogno di
sentire l’emozione nel battito del polso, servendosi di una
semplice Bic nero-china a punta sottile. Ne consumava decine
semplicemente perché le disseminava dappertutto e poi non le
trovava piú.
Cosí passavano i giorni, i mesi, gli anni senza speciali accadimenti,
a parte un viaggio ai confini orientali della Turchia (ma
Goliarda non fu mai una forte viaggiatrice geografica) e la
pubblicazione nel frattempo dei primi due romanzi. Intanto andavano
via quadri, disegni, sculture di tanti buoni artisti, e venivano ufficiali
giudiziari, pignoramenti, avvisi di sfratto. Finché arrivai io.
Ricordo che uno dei primi giorni che abitavo in via Denza, mentre
salivo le scale m’imbattei in una cassapanca del Settecento
austriaco che andava all’asta, pignorata in seguito a una vertenza
sindacale della donna di servizio da troppo tempo non pagata,
la comunque adorata Argia, a cui Goliarda rimase sempre grata nel
ricordo per l’aiuto che il suo prezioso lavoro domestico le
portò in quegl’anni impegnati a scrivere L’arte della gioia.
A datare dal nostro incontro Goliarda scrisse tutta la quarta e ultima
parte del romanzo, che fu concluso proprio nella mia casa
di Gaeta il 21 ottobre 1976. Apposi io stesso la data sul manoscritto,
e insieme cominciammo la sua revisione, poi dopo qualche
mese continuata solo da me, che durò sino a metà del 1978, anno in
cui partimmo per la Cina dopo aver dato il romanzo in
lettura, per il tramite di un noto critico, a uno dei maggiori editori. Al
ritorno, alla fine di quell’anno, trovammo la prima di una lunga
serie di risposte negative. La vita poi incalzò sempre piú pressante,
L’arte della gioia fu messo da parte, altre opere urgevano
dentro Goliarda. Si giunse al 1994, anno in cui io stesso curai la
pubblicazione presso Stampa Alternativa, casa editrice non
nuova a imprese coraggiose, di una prima parte del romanzo. Fu
allora che si pensò di procedere alle stampe dell’intera opera.
L’improvvisa morte di Goliarda ha voluto che fossi ancora una volta
io a preparare il romanzo per la sua edizione integrale.
Goliarda non potrà vedere la sua Modesta in libreria. Ma so che il
dolore non è piú suo, è tutto mio per lei. Goliarda non è piú.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :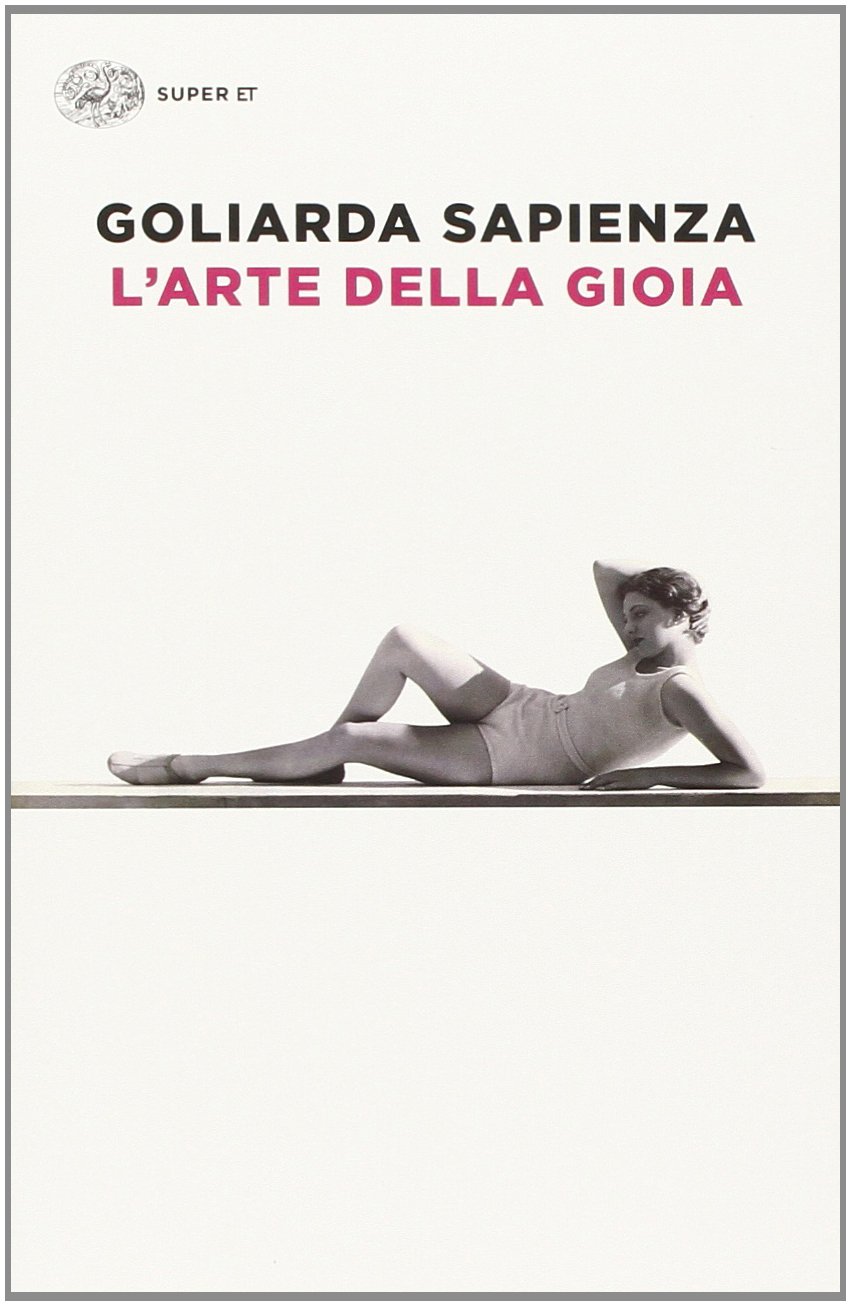






Commento all'articolo