Kafka – Per una letteratura minore – Gilles Deleuze
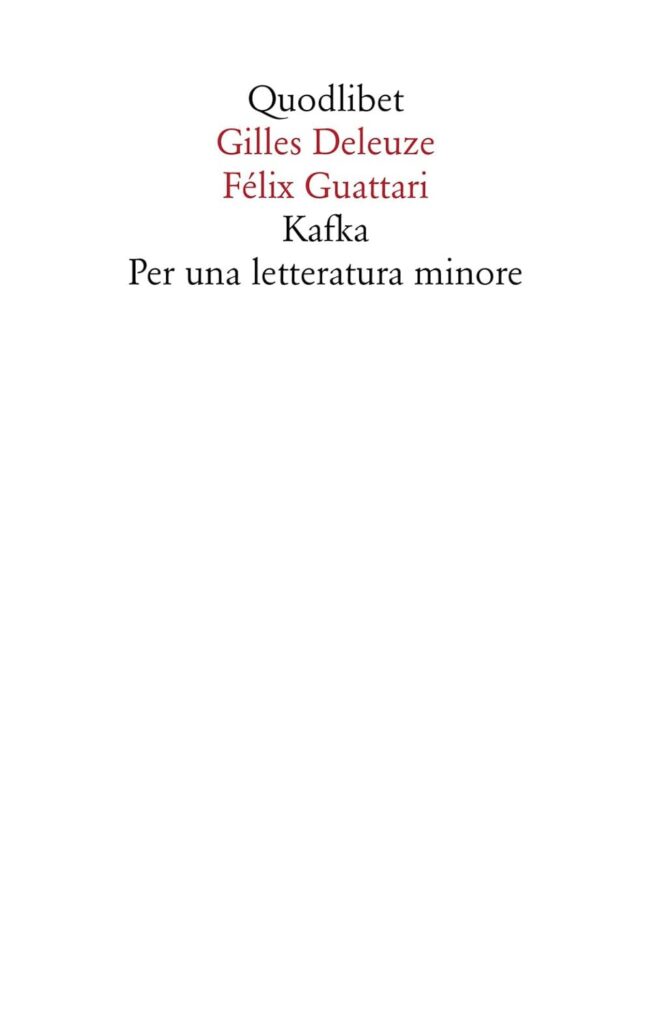
SINTESI DEL LIBRO:
Come entrare in un’opera come quella di Kafka? un’opera che è
un rizoma, una tana? Il Castello ha “molteplici ingressi” ma non si sa
bene quali siano le leggi che ne regolano l’uso e la distribuzione.
L’albergo di America ha innumerevoli porte, principali e secondarie,
custodite da altrettanti portieri, e persino degli ingressi e delle uscite
senza porte. Pare tuttavia che la Tana, nel racconto omonimo, abbia
una sola entrata - tutt’al più la bestia pensa alla possibilità di una
seconda entrata, che avrebbe una pura funzione di sorveglianza. Ma
è una trappola, della bestia e dello stesso Kafka; tutta la descrizione
della tana è fatta per ingannare il nemico. Si potrà quindi entrarvi da
un punto qualsiasi, non ce n’è uno che valga più dell’altro, nessun
ingresso è privilegiato, anche se si tratta quasi di un vicolo cieco, di
uno stretto budello, di un sifone e via dicendo. Ci si limiterà a cercare
a quali punti è connesso quello dal quale si entra, attraverso quali
diramazioni e gallerie si deve passare per mettere in connessione
due punti, qual è la carta del rizoma e quali le modificazioni
immediate che comporterebbe l’ingresso da un punto diverso. Il
principio degli ingressi molteplici è il solo a impedire l’introduzione
del nemico, il Significante, e i tentativi di interpretare un’opera che di
fatto si propone unicamente alla sperimentazione.
Prendiamo un ingresso modesto, quello del Castello, nella sala
dell’osteria in cui K1
scopre il ritratto di un portinaio dalla testa bassa,
con il mento schiacciato contro il petto. Questi due elementi, il ritratto
e la foto, la testa bassa, accasciata, sono costanti in Kafka, con
gradazioni di autonomia variabili. Foto dei genitori in America.
Ritratto della dama impellicciata nella Metamorfosi - in cui è la madre
reale a tenere la testa bassa, e il padre reale a indossare un
uniforme da usciere. Proliferazione di foto e ritratti nel Processo,
dalla camera della signorina Bürstner allo studio di Titorelli. La testa
bassa, che non si può più risollevare, ritorna continua-mente, nelle
lettere, nei Quaderni e nei Diari, nei Racconti, e persino nel
Processo, in cui i giudici hanno le spalle piegate contro il soffitto, una
parte degli assistenti, il carnefice, il prete... L’ingresso che noi
scegliamo non è dunque, come si potrebbe sperare, semplicemente
in connessione con altre cose a venire; esso è a sua volta costituito
dalla connessione stabilita fra due forme relativamente indipendenti,
la forma di contenuto “testa bassa” e la forma d’espressione “ritrattofoto”, che si ricongiungono all’inizio del Castello. Noi non
interpretiamo. Diciamo soltanto che questa riunione opera un blocco
funzionale, una neutralizzazione sperimentale di desiderio: la foto
incorniciata proibita, che non si può toccare né baciare, che non può
più godere di altra vista fuor della propria, come il desiderio
impacciato dal tetto o dal soffitto, il desiderio sottomesso che può
godere ormai solo della propria sottomissione. E anche il desiderio
che impone la sottomissione, la propaga, il desiderio che giudica e
che condanna - come il padre della Condanna, che china la testa al
punto di costringere il figlio a inginocchiarsi. Ricordo d’infanzia
edipico? Il ricordo è ritratto di famiglia o foto di vacanze, con signori
dalla testa bassa e dame dal collo coperto di nastri e pizzi2
. Il ricordo
blocca il desiderio, ne fa dei calchi, lo rovescia su strati, lo taglia da
tutte le sue connessioni. Ma allora, cosa ci resta da sperare? Si
tratta di un vicolo cieco, ma s’intende che anche un vicolo cieco è
buono, nella misura in cui può far parte del rizoma.
Il capo che si risolleva, la testa che sfonda il tetto o il soffitto
sembrano far riscontro alla testa bassa. Se ne hanno esempi un po’
dappertutto, in Kafka3
: nel Castello, appunto, al ritratto del portinaio
si contrappone la rievocazione del campanile del paese natio, che
“saliva su deciso, senza esitazione, rastremato in alto” (570) - anche
la torre del castello, come macchina di desiderio, evoca, su una
tonalità triste, il movimento di un abitante levatosi in piedi per
mostrarsi al mondo col risultato di sfondare il tetto. Ma allora
l’immagine del campanile non è ancora un ricordo? Di fatto non
agisce più come se lo fosse; agisce come blocco, non come ricordo
d’infanzia, raddrizzando il desiderio invece di piegarlo, spostandolo
nel tempo, deterritorializzandolo, facendone proliferare le
connessioni, facendolo passare in altre intensità - il blocco torre-
campanile, per esempio, passa in altre due scene, quella del
maestro e dei bambini, di cui non si capisce quello che dicono, e
quella della famiglia spostata, raddrizzata o rovesciata, in cui sono
gli adulti a fare il bagno nel mastello. Ma non è questo ciò che conta.
Quello che conta è la musichetta, o meglio l’intenso suono puro che
viene dal campanile e dalla torre del castello: “Un tocco di campana,
alato e giocondo, un tocco che faceva tremare il cuore almeno per
un istante, quasi lo minacciasse - perché il tocco era anche doloroso
- l’adempimento dei suoi incerti desideri. Ma la grande campana
tacque subito, e fu sostituita da una campanella fioca e monotona...”
(C., 579). È curioso come in Kafka l’intrusione del suono avvenga
spesso in connessione con il movimento di sollevare o risollevare la
testa: Giuseppina la cantante; i cagnolini musicanti - “Tutto era
musica, il modo di alzare e posare i piedi, certi movimenti del capo
[...] camminavano ritti sulle zampe posteriori [...] risollevavano subito
le gambe” (R., 461-4). Ma è soprattutto nella Metamorfosi che si ha
la distinzione fra due stati del desiderio, da una parte quando
Gregorio si appiccica al ritratto della dama in pelliccia e volge la
testa alla porta, nello sforzo disperato di salvare qualche mobile
della sua stanza, che i familiari stanno sgomberando; dall’altra
quando Gregorio abbandona la stanza guidato dal suono vacillante
del violino e si propone di arrampicarsi sino al collo nudo della
sorella - che non porta più golette e sciarpe da quando ha perduto la
sua posizione sociale. Differenza fra un incesto plastico ancora
edipico, su una foto materna, e un incesto schizo, con la sorella e la
strana musichetta che da lei proviene? La musica sembra sempre
presa in un divenir-bambino, o in un divenir-animale non
scomponibile, blocco sonoro che si oppone al ricordo visivo.
“Spenga la luce, per favore! So suonare soltanto al buio. E mi
rizzai”4
. A quanto pare abbiamo qui due forme nuove: testa alta
come forma di contenuto, suono musicale come forma
d’espressione. Si ottengono così le seguenti equazioni:
Non ci siamo ancora. Non è certo la musica organizzata, la forma
musicale, che interessa Kafka - dalle lettere e dai diari si ricavano
solo pochi aneddoti insignificanti su alcuni musicisti. Non è tanto una
musica composta, semiotica-mente formata, a interessare Kafka,
quanto una pura materia sonora. Se si percorrono le principali scene
di intrusione sonora si ottengono pressappoco i seguenti dati: il
concerto alla John Cage, in Descrizione d’una battaglia, in cui 1)
l’Orante vuole suonare il piano perché sta per essere felice; 2) non
sa suonare; 3) non suona affatto (“Due dei presenti sollevarono la
panca e mi portarono lontano dal pianoforte verso la tavola
apparecchiata fischiando una canzone e dondolandomi
leggermente” [R., 40]); 4) i presenti si congratulano con lui per
l’eccellente esecuzione. In Indagini d’un cane, i cani musicanti fanno
un gran baccano, ma non si sa come: non parlano, non abbaiano e
non cantano ma fanno sorgere la musica dal nulla. In Giuseppina la
cantante o il popolo dei topi, è improbabile che Giuseppina canti;
fischia semplicemente, e non meglio di un altro topo, anzi, peggio,
cosicché il mistero della sua arte inesistente si fa sempre più fitto. In
America, Karl Rossmann suona o troppo in fretta o troppo adagio,
fino al ridicolo, mentre sente “nascere dentro di sé, a poco a poco,
una nuova canzone” (89). Nella Metamorfosi, il suono entra in scena
dapprima come pigolio che si mescola alla voce di Gregorio e
confonde la risonanza delle parole; e, in un secondo momento, la
sorella, che pure è buona musicista, non riesce a cavare dal violino
altro che una specie di pigolio, disturbata dall’ombra dei pensionanti.
Basteranno questi esempi a dimostrare che il suono non si
oppone al ritratto nell’espressione come la testa alta si oppone alla
testa bassa nel contenuto. Fra le due forme di contenuto, se
considerate astrattamente, c’è sì una opposizione formale semplice,
una relazione binaria, un tratto strutturale o semantico che, appunto,
non ci porta molto fuori del “significante” e forma una dicotomia più
che un rizoma; ma se il ritratto, per parte sua, è una forma
d’espressione che corrisponde alla forma di contenuto “testa bassa”,
altrettanto non si può dire del suono. Ciò che interessa Kafka è una
pura materia sonora intensa, sempre in rapporto con la propria
abolizione, suono musicale deterritorializzato, grido che sfugge alla
significazione, alla composizione, al canto, alla parola, sonorità in
rottura per liberarsi da una catena che è ancora troppo significante.
Nel suono conta solo l’intensità, generalmente monotona, sempre
asignificante; si veda, per esempio, nel Processo, il grido su una
sola tonalità del custode che si fa fustigare, un grido che “pareva
venisse non da una creatura umana, ma da uno strumento
martoriato” (397)5
. Finché c’è forma c’è riterritorializzazione, anche
nella musica. L’arte di Giuseppina consiste invece nel fatto che, pur
non sapendo cantare meglio degli altri topi e fischiando semmai
meno bene, essa opera forse una deterritorializzazione del fischio
tradizionale e lo libera dalle catene dell’esistenza quotidiana. In altre
parole, il suono non appare qui come una forma d’espressione bensì
come una materia non formata d’espressione, destinata a reagire
sugli altri termini. Da una parte servirà a esprimere i contenuti che si
riveleranno relativamente sempre meno formalizzati. La testa che si
risolleva non ha più quindi una propria e formale validità, essa è
soltanto ormai una sostanza deformabile, trascinata e trasportata dal
flutto d’espressione sonora - come Kafka fa dire alla scimmia di
Relazione per un’Accademia, non si tratta del movimento verticale
ben formato in direzione del cielo o in avanti, non si tratta di sfondare
il tetto ma di filare “a capofitto ”, non importa dove, anche da fermi,
intensamente; non si tratta di libertà contrapposta a sotto-missione
ma solo di una linea di fuga, anzi di una semplice via d’uscita, “a
destra, a sinistra, purché fosse” (R., 270) la meno significante
possibile. D’altra parte, le formalizzazioni più solide, più resistenti,
quelle del tipo ritratto, o testa-bassa, perderanno anch’esse la loro
rigidità per proliferare o preparare un sollevamento che le faccia
filare lungo linee d’intensità nuove - anche la schiena curva dei
giudici emette uno scricchiolio sonoro che spedisce la giustizia in
soffitta; e le foto, i quadri, prolifereranno nel Processo assumendo
una funzione nuova. I disegni di Kafka, gli omini e le sagome lineari
che egli ama scarabocchiare, sono soprattutto teste basse, teste alte
o rialzate, e capi-fitti - se ne vedano le riproduzioni nel numero di
“Obliques” dedicato a Kafka.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :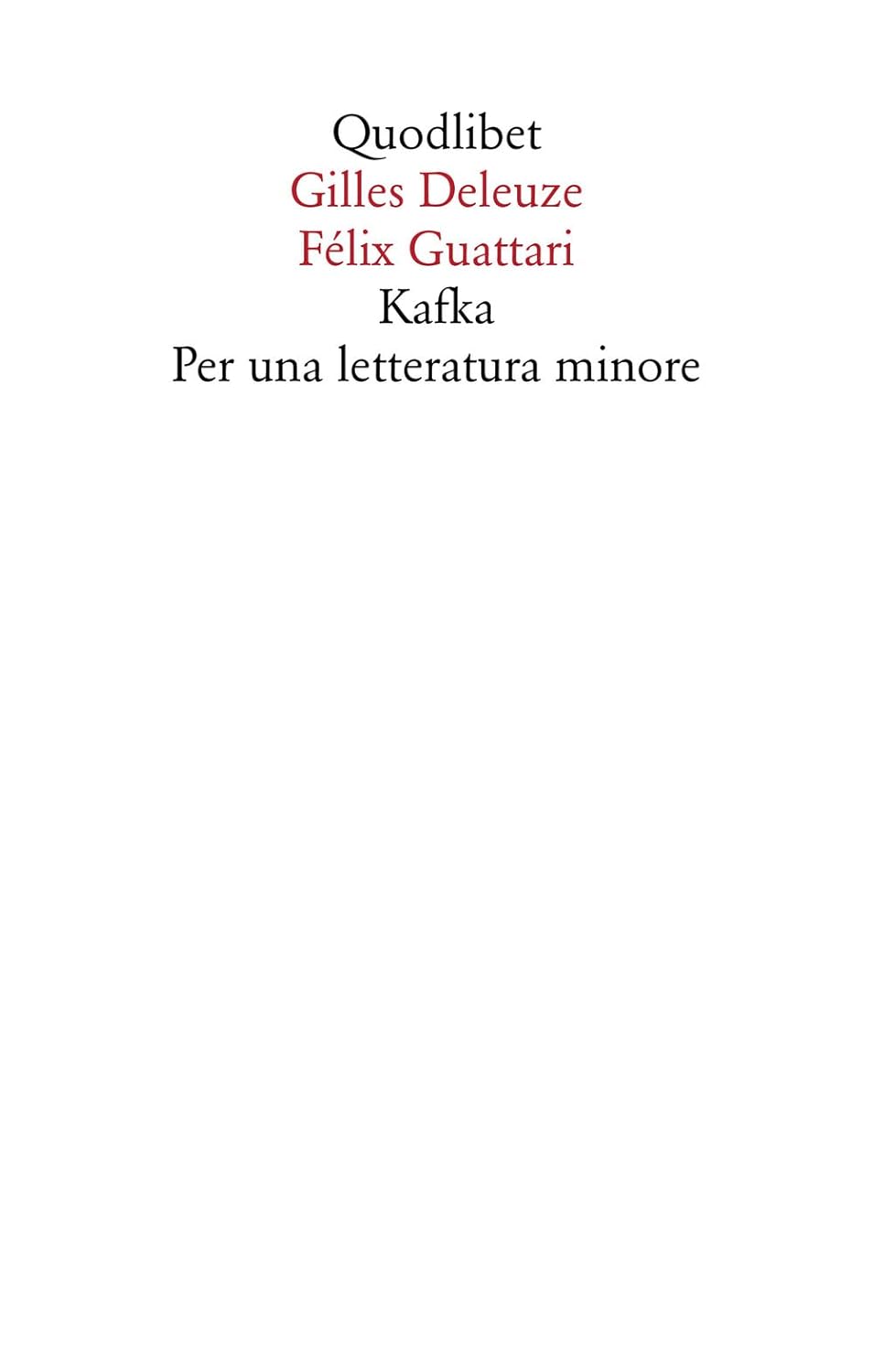



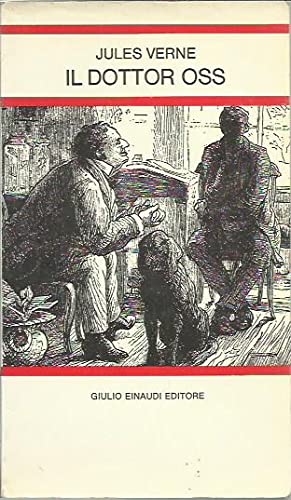
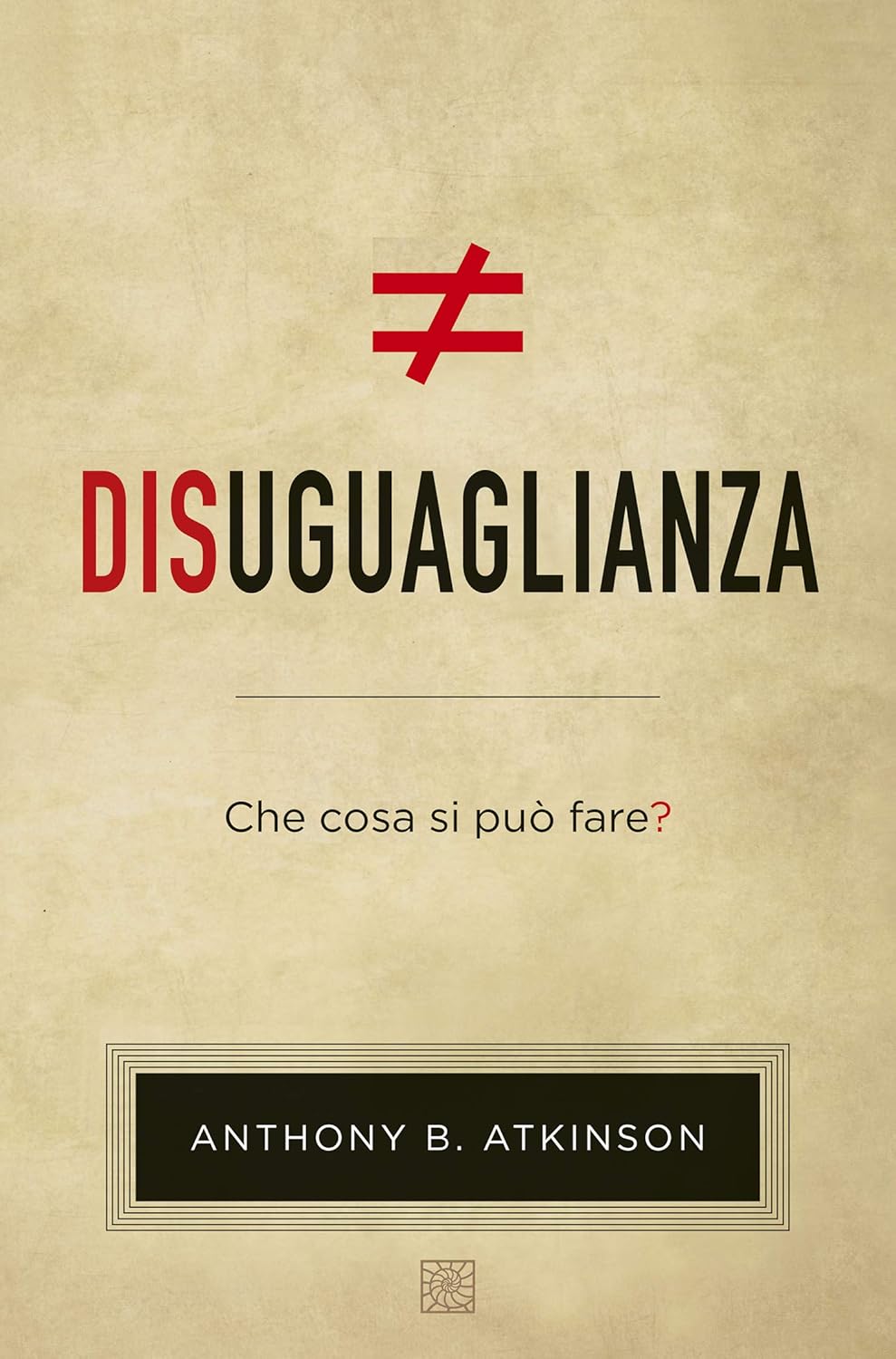
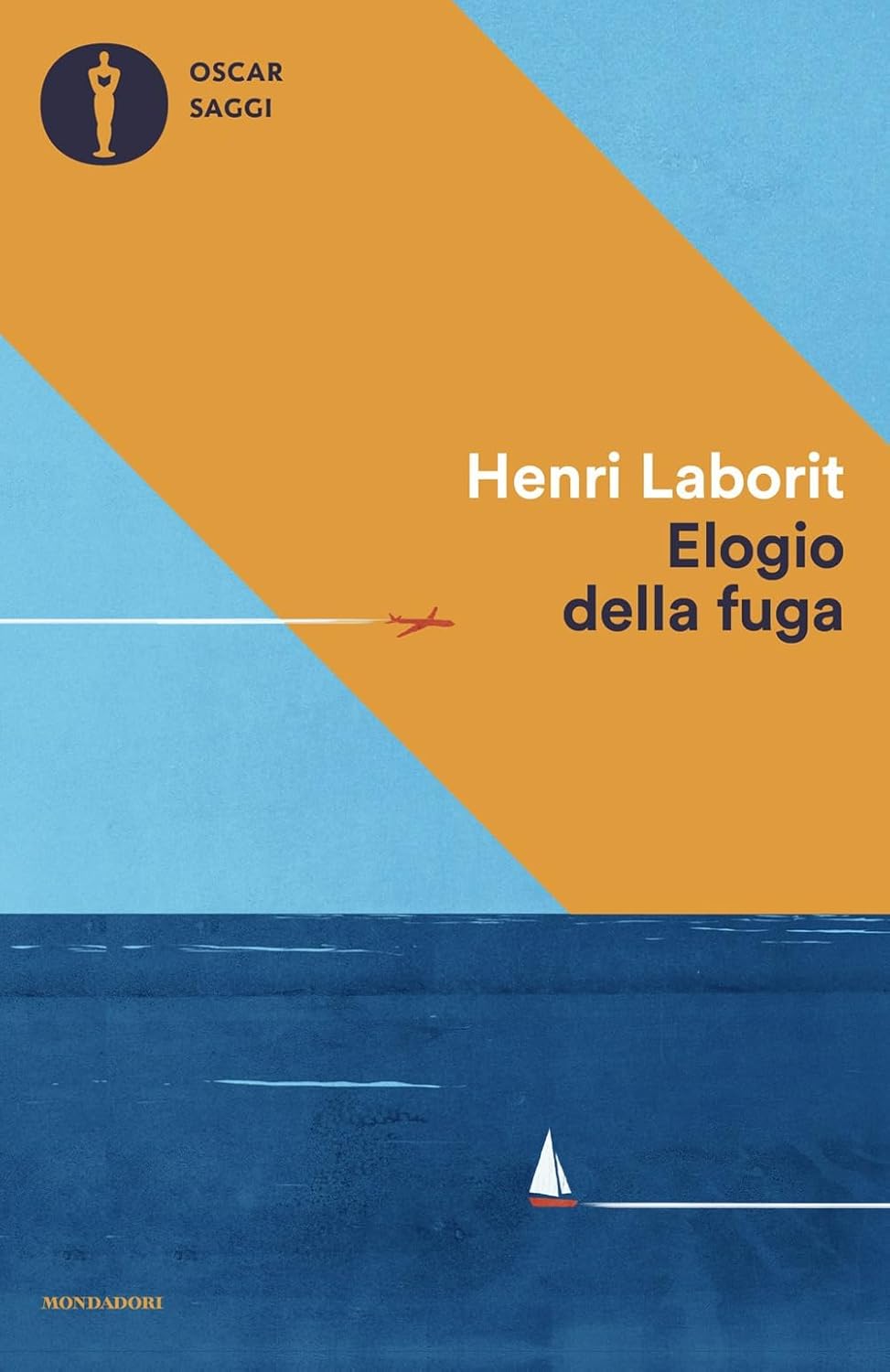
Commento all'articolo