Dante. Una vita in esilio – Chiara Mercuri
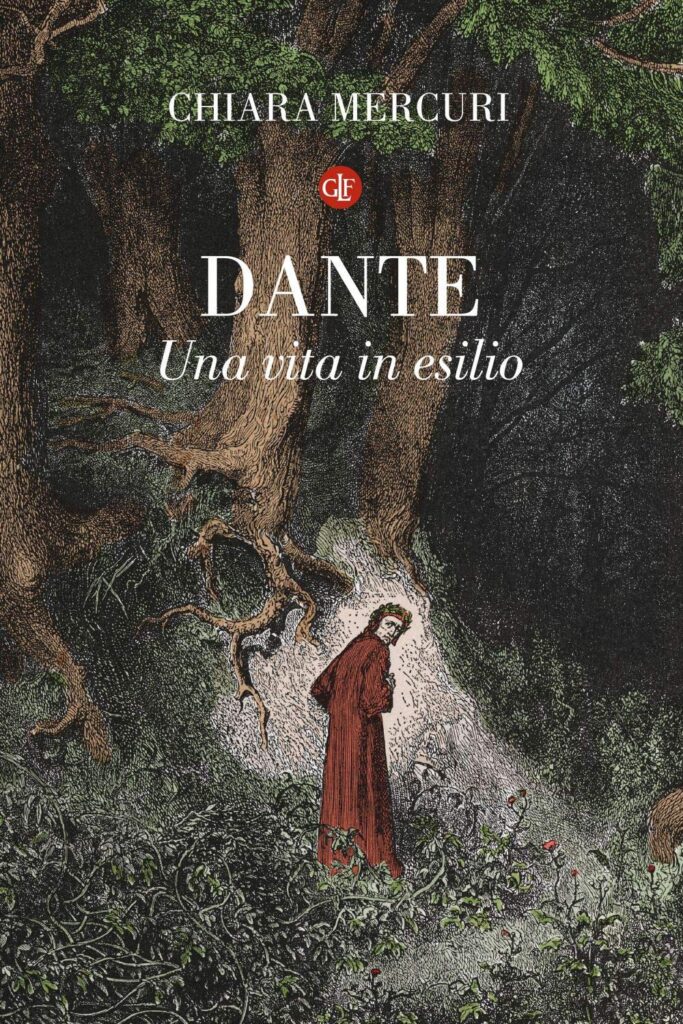
SINTESI DEL LIBRO:
Dopo la sentenza, Dante capisce che è tempo di allontanarsi da Roma,
anche se non per rientrare a Firenze, come aveva sperato nei mesi
precedenti. Vuole lasciarsi alle spalle quei reticoli di strade tentacolari,
quei monumenti smozzicati, quei basoli dissestati, che devono apparirgli
ora come una selva intricata ed ostile da cui sia difficile svincolarsi.
Roma, con la sua parabola di trionfo e caduta, è una metafora troppo
esplicita della sconfitta. Non è l’esempio della caducità dell’esistente che
Dante vuole avere sotto gli occhi; non la desolazione di un passato che
frana e va in rovina con le sue immense aree urbane trasformate in
pascolo; non i templi dissestati e negletti, non i muri rattoppati con
marmo di riutilizzo: un volto, una mano, un busto, intrappolati a
brandelli nella calce grezza.
Come disfatta gli basta la sua, non c’è bisogno di alcun paesaggio
esteriore a ricordargliela.
Riguadagnare la Toscana con i suoi orizzonti aperti, con le sue verdi
colline, con i suoi paesaggi familiari, potrebbe invece essergli salutare.
Dalla Toscana Firenze è vicina, sembrerà quasi di poterla toccare. La
moglie e i figli sono probabilmente già altrove, nel contado fiorentino, e
in ogni caso a Firenze sarebbero più al sicuro, lui assente.
In Toscana, può riunirsi ai fuoriusciti che a centinaia la popolano: quelli
che, capaci di leggere gli eventi, sono fuggiti per tempo, prima che Carlo
di Valois vi mettesse piede; quelli che nella notte del 5 novembre, allertati
dai falsi speziali, si sono allontanati per non cadere vittime delle
rappresaglie; quelli a cui, dopo l’arrivo di Carlo di Valois, sono state fatte
violenze; quelli che sono già stati condannati dai tribunali speciali.
Riunire e riunirsi a questa torma di derelitti, a quest’ammasso di gente
violata nell’anima, è ora la priorità. Riunirsi e curare le ferite attraverso
l’azione, organizzando la resistenza, tentando di rovesciare il governo dei
neri che ha travolto la signoria pacifica di Dino Compagni.
In questi anni, che sono quelli contrassegnati dal maggiore sforzo
politico di Dante, egli oscilla in bilico tra diverse strade, tutte quelle che
possono riportarlo a Firenze. La prima che egli tenta è quella del rientro
armato, insieme a quelli del suo gruppo. Li incontra una prima volta nel
castello di Gargonza, sulla via che corre tra Siena ed Arezzo,
probabilmente già nel febbraio del 1302, appena lasciata Roma. Con loro
dà vita ad un’associazione denominata «Università dei bianchi di
Firenze», secondo il significato medievale che aveva la parola «università»,
di unione, corporazione, congregazione. All’interno dell’università, a
Dante viene assegnato il ruolo di segretario, il che vuol dire di voce e
anima del gruppo, senza che egli rinunci a partecipare del tutto agli
scontri armati.
Qualche mese più tardi, nel giugno del 1302, presso la pieve di San
Godenzo, al confine tra Mugello e Val di Sieve, Dante li incontra
nuovamente. Sappiamo con certezza che a questo incontro presero parte
due figure chiave degli scontri di quegli anni: Vieri de’ Cerchi e Lupo
degli Uberti. Di Vieri abbiamo già parlato, è l’ex capo del suo partito e
naturalmente è in esilio come Dante; Lupo degli Uberti, invece, è il
nipote di quel Farinata, che – come vedremo – Dante aveva conosciuto
molti anni prima in circostanze insolite e che proviene, invece, dal partito
dei ghibellini.
Lo strano abbraccio celebrato a San Godenzo tra l’ex capo dei guelfi
bianchi e il nipote dell’ex capo dei ghibellini di Firenze dovette avere –
dal punto di vista simbolico – un valore enorme che noi oggi
difficilmente capiamo. Due forze tradizionalmente nemiche ora si
compattavano – ufficialmente – davanti al nemico comune. A partire da
questo momento i neri approfitteranno dell’esplicitarsi di questa nuova
ibrida alleanza per accusare i bianchi di tradimento della patria.
Incuranti delle accuse, decisi a liberare Firenze a qualunque costo,
bianchi e ghibellini si gettano in una serie ripetuta di scontri, ma dopo
alcuni successi, nell’autunno del 1302, la lega dei fuoriusciti comincia a
perdere colpi e a subire, di lì in avanti, pesanti sconfitte. Sono uomini
incapaci di pianificazione e strategia, i fuoriusciti. Sono uomini che
l’esilio ha reso solo più caparbi, fornendo loro una ragione personale –
oltre che politica – al rientro. Uomini che l’esilio ha colpito con una forza
d’urto tale da provocare in loro l’istinto alla reazione pur che sia. Una
reazione che li riscatti dall’essere vittime inermi, che li affranchi
dall’umiliazione subita: meglio morire nel gesto di rientrare che
rassegnarsi ad un’esclusione impotente.
Torneranno in trionfo – questo immaginano –, torneranno in trionfo,
ripulendo la loro reputazione infangata. Torneranno come era tornato
Cesare, perché non era Roma che serviva a Cesare, ma Cesare che serviva
a Roma. E se, per farvi ritorno, Cesare dovette imporsi, dovette vincere i
veti senatoriali, osare l’impensabile, portare un esercito dentro i confini
della città, loro faranno lo stesso, combattendo con decisione il potere
corrotto che tiene in ostaggio Firenze. Per farsi forza, gli sbanditi devono
concentrarsi su quel ritorno: devono scandagliarlo, immaginarlo,
pregustarlo. Come quello di Cesare, sarà un rientro strafottente, che
dovrà essere di lezione alla classe politica che li ha messi al bando.
Lo sforzo di Dante, in questa fase della sua vita, è tutto proteso a farsi
dunque nuovo Cesare per i fuoriusciti; un uomo cioè capace di
trasformare pezzi singoli in un tutt’uno compatto e coeso. Ma i
fuoriusciti non sono stati plasmati dalla retorica di Roma, non sono stati
resi affini da lunghe campagne di guerra, non hanno davanti a loro nemici
stranieri ben distinguibili da loro, non sono motivati dalla promessa di
terre da coltivare e da amministrare, come lo erano i legionari di Cesare.
Sono un gruppo raccogliticcio di cavalieri provenienti da famiglie già
ricche e già in vista. Famiglie che per giunta non hanno mai brillato per
una visione unitaria o per una linea politica coerente, e che non hanno
saputo accettare i sacrifici e le rinunce che una linea chiara avrebbe
imposto loro. Famiglie che al contrario si sono sempre contraddistinte per
l’odio viscerale, per le piccole rivalse, per le reciproche invidie, per le
meschine gelosie. Egli crede davvero di ricompattare un gruppo così
sfilacciato e difforme?
Dante non è Cesare, non saprà fare del suo ritorno la più grande
dimostrazione di sé, l’apice della sua carriera. Di Cesare non ha
l’ambizione, l’amore per il comando, il carattere aperto ed amabile, la
capacità di seduzione. Di Cesare non possiede la più sublime delle virtù
politiche: l’arte della dissimulazione. Non possiede neppure la pazienza
dell’attesa e il controllo della strategia. Nulla in Cesare è istintivo, tutto è
pianificato, come pianificate al millimetro sono le sue battaglie. La sorte
non va né forzata né frenata, va compresa ed affiancata con lucidità. Una
lucidità che a Dante manca, una capacità d’attesa che non ha mai
conosciuto, perché Dante non è un politico, non è uno stratega, al
contrario è un istintivo puro, un impulsivo, un irascibile. Qualità che in
battaglia gli hanno guadagnato un posto tra i feditori, gli uomini di prima
linea, cavalieri scelti per lo sfondamento. Dante è uno che si getta nella
guerra col cuore e col coraggio, come nella vita, d’impeto e non di testa.
2. Arezzo
Dopo gli incontri a Gargonza e a San Godenzo, Dante prende dimora
stabile, insieme a molti altri fuoriusciti, ad Arezzo, dove in quel momento
è podestà Uguccione della Faggiola, nemico storico di Firenze.
Arezzo è una delle più convinte roccaforti del ghibellinismo toscano e
infatti accoglie fuoriusciti fiorentini, nonostante le minacce e i divieti di
Firenze a farlo. Con i suoi 13.000 abitanti si presenta agli occhi di Dante
molto diversa dalla sua città. Comignoli fumanti, e mura di pietra, e case
e botteghe di merci ricche ci sono anche qui ad Arezzo, ma l’Appennino
non la corteggia dolce, la minaccia invece con le sue foreste cupe, pronte
a perdere chiunque vi si addentri appena di un passo. E perdersi è facile
per chi già sbandi, per chi già non riesca a vedere se non tronchi infuocati
e strade deserte e paesaggi lunari, a tratti infernali.
È probabilmente colpa dell’Arno, che invece d’ingentilirla col passaggio
delle sue acque, proprio mentre sembra avvicinarsi, d’improvviso le volge
«il muso», rifiutando di entrare in città.
Botoli trova poi, venendo giuso,
ringhiosi più che non chiede lor possa,
e da lor disdegnosa torce il muso.
[L’Arno poi, scorrendo verso il basso, trova i cani aretini, che ringhiano più di quanto ne
abbiano forza, e da loro devia il suo corso volgendo loro disdegnoso il muso.]
(Purgatorio, XIV, 46-48)
A torcere «il muso» ad Arezzo non è solo l’Arno, ma anche la
rivoluzione finanziaria e mercantile che, al contrario, sta facendo grande
Firenze. Di prestatori lucchesi, senesi, pisani, pistoiesi, fiorentini ve n’è in
ogni dove nell’Occidente cristiano, ma di prestatori aretini non se ne
incontra neppure uno.
Eppure, a differenza di Firenze, Arezzo ha un suo studium, una facoltà di
Diritto, che non le basta però per avvicinarsi alla grandezza della sua
vicina, che avanza veloce verso il nuovo, mentre lei arranca lenta, ancora
impastoiata nei lacci del vecchio sistema feudale. Uno stuolo di potenti e
riottose famiglie aristocratiche le si sollevano contro di continuo dal
contado; la premono, le portano i loro atavici contrasti fin dentro le mura
cittadine, impedendo la nascita di quella classe media, affaristicoborghese, che sta facendo grandi le altre città della Toscana.
Ubertini e Tarlati la tengono in ostaggio con i loro livori personali, con
la loro cupidigia, con le loro estenuanti lotte per la conquista del
vescovado. Una carica che qui – tra gli speroni dell’Appennino – è
svuotata di qualsivoglia valore spirituale. Non sono uomini di Dio questi
vescovi. Non sono amanti degli eremi solitari e della cura delle anime
quelli che qui inseguono la mitra, sono rampolli feroci di casate
antagoniste, decise a sfruttare ogni via per prendere il controllo della città.
Uno strano tipo di vescovo, quello che proviene dalle fila degli Ubertini
e dei Tarlati: un patriarca che in luogo di benedire processioni col
pastorale, le asperge con la mazza chiodata; un prelato che attende
impaziente di scendere in battaglia solo per randellare i nemici come fosse
il più feroce dei laici. Uno di questi vescovi, Guglielmo degli Ubertini,
Dante se l’era trovato di fronte proprio a Campaldino. E a questo vescovo,
che bellicoso guidava lo schieramento antifiorentino, Dante e i suoi
avevano dato la morte. Dev’essere, dunque, strano ora per Dante scegliere
proprio Arezzo come rifugio per il suo esilio. Meno strano per Arezzo –
l’abbiamo detto – fornire accoglienza ed aiuto a chiunque si sia fatto
nemico di Firenze.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :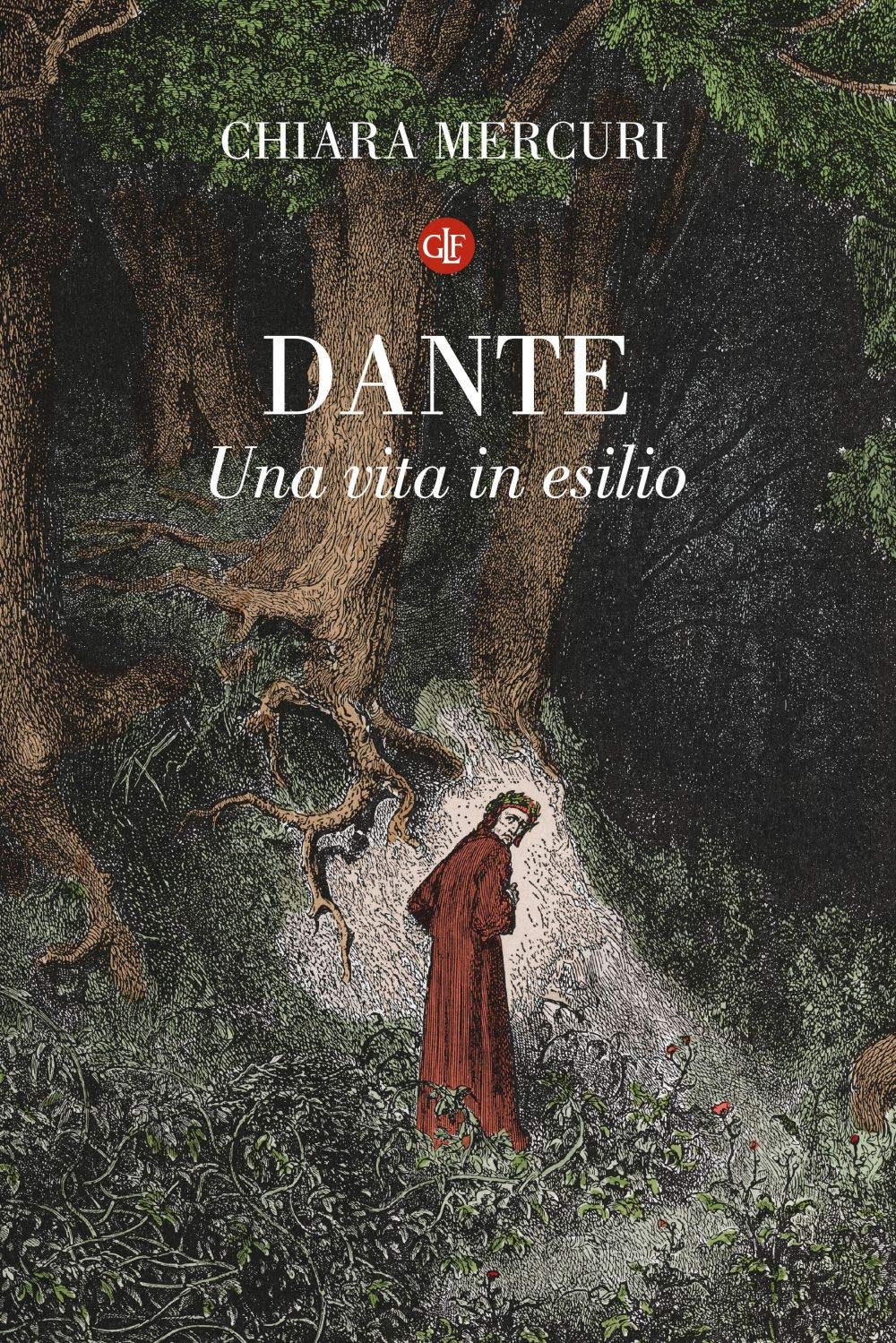






Commento all'articolo