Le virtù del buon musulmano- Ida Zilio-Grandi
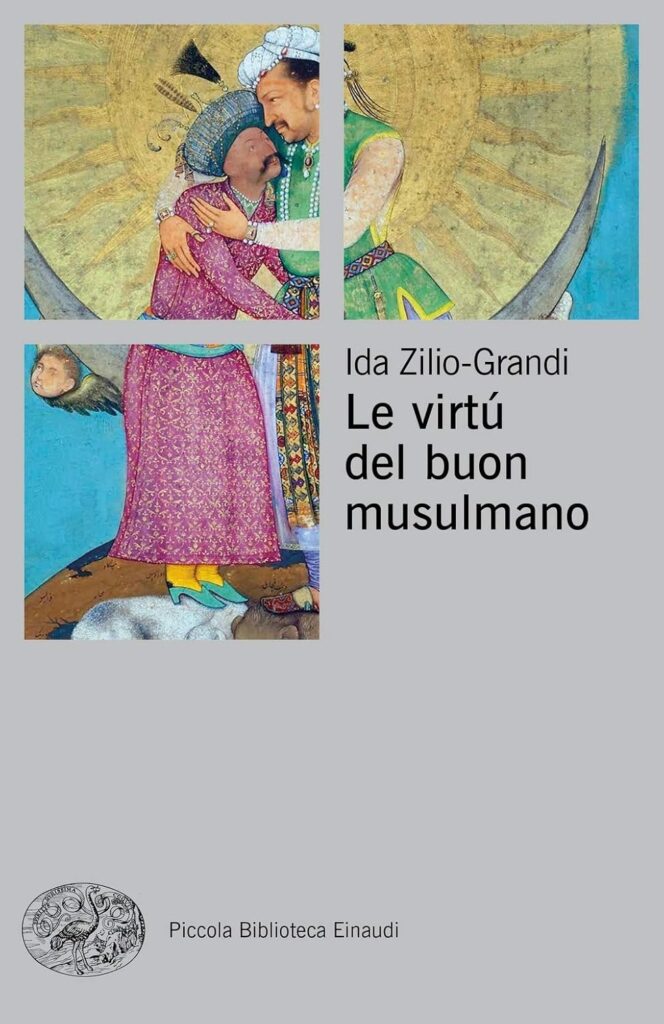
SINTESI DEL LIBRO:
Le virtú del buon musulmano spiccano su due sfondi diversi: da
una parte le qualità divine, i «Nomi Bellissimi», ai quali, o almeno
alla maggior parte dei quali, il credente cercherà di conformarsi
secondo le sue possibilità umane; e dall’altra parte l’amore di Dio,
esplicitamente richiamato nel Corano in relazione ad alcune
categorie di credenti e alle loro qualità. Due cornici differenti, che
tuttavia si richiamano a vicenda visto che il Corano, la Sunna del
Profeta e piú ancora il lavoro successivamente condotto da teologi e
giuristi a spiegazione e sostegno della tradizione testuale affermano
per molte vie che Dio ama chi Gli somiglia. E questo vale certamente
per la pazienza, in arabo ṣabr, la virtú che sopra ogni altra qualifica il
buon credente. Da una parte, infatti, la tradizione riconosce a Dio il
Nome al-Ṣabūr, «il Pazientissimo», situato al novantanovesimo
posto nelle piú accreditate liste dei Nomi divini 1
; e si badi che la
posizione finale di questo Nome non implica affatto un suo minimo
statuto, al contrario, giacché esso prelude e introduce al Nome
supremo che Dio solo conosce. Dall’altra parte il Corano dichiara
con decisione l’amore di Dio per i pazienti (al-ṣābirūn). È la sura
della Famiglia di ‘Imrān:
Quanti profeti hanno combattuto, e con essi molti dei loro devoti, ma non
hanno perduto coraggio per quel che li aveva colti sul sentiero di Dio, non si
sono infiacchiti, né umiliati, Dio ama i pazienti (Corano 3,146).
La pazienza rientra dunque a pieno titolo nei due quadri sopra
delineati: l’imitabilità delle qualità divine mutatis mutandis, e
l’amabilità dell’uomo agli occhi del creatore. Per di piú, e peraltro
come la piú generica «pietà» (o «timor di Dio», taqwā), la pazienza
partecipa di uno statuto particolare, che la solleva sulle altre qualità
richieste al musulmano e ne accresce la nobiltà: la «compagnia di
Dio» (ma‘iyya, da ma‘a, «insieme a»).
1. «Sii paziente di pazienza bella» (Corano 70,5).
La sura della Vacca esorta i fedeli cosí: «Voi che credete, aiutatevi
con la pazienza e la preghiera, Dio è con i pazienti» (Allāh ma‘a alṣābirīn; Corano 2,153); poco piú avanti nella stessa sura, dove è
ripresa la storia biblica del pio Davide e dell’empio Golia (cfr. 1
Samuele 17,1-53), il Libro ribadisce:
… molte volte è accaduto che piccoli eserciti prevalessero su eserciti
consistenti, con il permesso di Dio, Dio i pazienti li accompagna. E quando
affrontarono Golia e le sue truppe, dissero: «Signore nostro, colmaci di
pazienza, rendi saldi i nostri piedi e donaci la vittoria sul popolo dei miscredenti»
(2,249-50).
Applicata alla pazienza, la «compagnia di Dio» – si tratti solo del
Suo sostegno, del Suo supporto nella vittoria contro gli infedeli e del
Suo compiacimento per le azioni dei buoni, come vuole l’esegesi
maggioritaria; si tratti invece del piú alto e persistente grado della
prossimità a Lui, come suggeriscono gli autori spirituali – ricompare
nella sura del Bottino:
Ubbidite a Dio e al suo inviato, e non discutete, altrimenti perdereste fiducia e
vigore, e il vento che vi ha favorito girerebbe. Siate pazienti, Dio è con i pazienti.
(…) Adesso, Dio ha alleggerito il vostro compito, Egli conosce la vostra
debolezza. Se tra voi ci sono cento uomini pazienti, ne vinceranno duecento, e,
con il permesso di Dio, mille ne vinceranno duemila, Dio è con i pazienti (8,46 e
56).
L’abbondante presenza della pazienza nel Corano, con l’elogio
che essa riceve dalle parole divine è la prova dirimente della sua
importanza nel pensiero morale islamico. Compare naturalmente nel
caso di Giobbe/Ayyūb (Corano 38,44), con un’estensione perfino piú
marcata rispetto all’antecedente biblico. La pazienza è la
caratteristica dei profeti (6,34; 14,12; 46,35), e segnatamente di
Mosè (14,5; 18,69; 21,85; 38,12), Ismaele, Idrīs, Dhū l-Qifl (21,85),
Giacobbe (12,18), Giuseppe e suo fratello (12,90), Noè (38,12), Lot
(38,13), gli inviati degli ‘Ād, dei Thamūd e di al-Ayka (38,12-13), e il
figlio che Abramo avrebbe sacrificato a Dio (37,102). La pazienza
qualifica quanti seguirono il Profeta nell’egira, il trasferimento dalla
Mecca a Medina (16,42 e 110); e tutti coloro che temono Dio e sono
sinceri (2,177), tutti i devoti, i generosi (3,17), i riconoscenti (31,31),
coloro che si raccomandano a vicenda la compassione (90,17) e la
verità (103,3). Gli uomini e le donne allo stesso modo: com’è detto
nella sura delle Fazioni Alleate,
… gli uomini e le donne sottomessi al Signore, i credenti e le credenti, i
devoti e le devote, gli uomini che dicono la verità e le donne che dicono la
verità, gli uomini e le donne che hanno pazienza, che hanno umiltà, che
versano l’elemosina e digiunano e conservano la castità e spesso rammentano
il nome di Dio, per tutti Dio ha preparato un perdono e una generosa
ricompensa (33,35).
La pazienza porta vittoria (6,34) e sopravvento (8,65-66), buon
esito (7,128; 11,49), premio (28,80) e ricompensa (11,11 e 115;
16,96; 29,59; 39,10), ricompensa doppia (28,54), appagamento
(20,130) e beatitudine celeste (13,22-24; 25,75; 76,12); provoca il
perdono del Signore (11,11) e trasforma il nemico in buon amico.
Com’è detto nella sura dei Chiari e precisi,
… la buona e la cattiva azione non sono uguali; tu rispondi con quella
migliore e il nemico sarà per te un amico sincero. Questo grado lo raggiungono
solo quelli che hanno avuto pazienza (41,34-35).
Simile un versetto nella sura del Racconto: «Riceveranno due
volte la loro ricompensa perché sono pazienti, perché ripagano il
male con il bene» (28,54). Spesso la pazienza figura come
metonimia per la stessa condizione di credente, come dire che la
sua presenza basta da sola a definire il musulmano.
Sempre la pazienza è la ripetuta raccomandazione di Dio a
Muḥammad: «Sii paziente di pazienza bella» recita la sura delle
Scale (70,5). Il Corano chiama il Profeta alla pazienza affinché non
disperi e confidi in Dio che è il Giudice sommo (10,109; cfr. 52,48),
perché sia fiducioso nella Sua promessa veritiera (30,60; 40,55 e
77), nel Decreto che premia i buoni (11,49; 11,115; 68,48; 74,7;
76,24) e annienta i malvagi (46,35; 70,5); affinché si stringa ai suoi
Compagni (18,28), non si lasci traviare dalle insidie (16,127) o dalle
parole (20,130; 38,17; 50,39; 73,10) degli increduli, e non ceda alla
tristezza (ancora 16,127).
Ancora nel Corano, la pazienza figura tra le raccomandazioni che
il saggio Luqmān fece a suo figlio affinché conducesse una vita
buona, responsabile oltre che pia: «Figlio mio, adempi alla
preghiera, ordina il bene e impedisci il male, e sopporta
pazientemente le sventure che ti colpiscono. Ecco la ferma condotta
da seguire nelle azioni» (31,17). E quest’ultima è una ricorrenza
molto interessante, perché Luqmān, pur descritto nel Libro con i tratti
del buon musulmano, è un saggio (cfr. ḥikma in 31,12) e non un
profeta; in questo modo, la pazienza valica i confini della religione e
assume una valenza secolare e umanistica.
2. Resistenza, custodia, impassibilità.
La pazienza è la massima virtú del musulmano autentico.
Tuttavia, la «pazienza» dell’Islam non è semplicemente quella
disposizione d’animo che fa accettare i rovesci della sorte con
moderazione e in serenità: è sí l’accettazione rassegnata delle
avversità, essendo la gratitudine a Dio (shukr) il suo reciproco nella
buona sorte (Corano 31,31); è la quieta sottomissione al giudizio
divino, peraltro premessa di vittoria e successo (8,66; 18,69; 23,111;
76,24); è l’assoluta fiducia nel superiore Disegno, che infine equivale
alla fede (īmān). Ma è anche il comportamento sereno di chi si
accontenta, è tolleranza e moderazione nei confronti degli altri
(3,200); nonché la tenacia e la perseveranza nell’atto cultuale (2,45;
18,28; 20,132). In tal modo, l’espressione italiana «pazienza»
sembra insufficiente a coprire l’esteso ambito semantico del termine
arabo corrispondente.
La traduzione di ṣabr con pazienza apparirà tanto piú inadeguata
pensando ai diversi presupposti etimologici dei due termini: da una
parte sopportazione e patimento (cfr. ad esempio passio e πάθoς),
dall’altra trattenimento, resistenza e custodia: della lingua dalle
lagnanze, degli arti dalla violenza, e anche dai cibi, dalle bevande e
dai rapporti sessuali durante «il mese della pazienza», un modo per
dire il Ramadan 2
. Ṣabr è anche il nome dell’aloe, pianta capace di
trattenere l’acqua e di resistere al caldo e alla siccità senza
apparenti variazioni o pena. E, appunto, è solo perché non rimanda
necessariamente alla sofferenza ma può coincidere, tutto al
contrario, con l’impassibilità, che al-Ṣabūr o «il Pazientissimo» può
essere concepito come un Nome divino.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
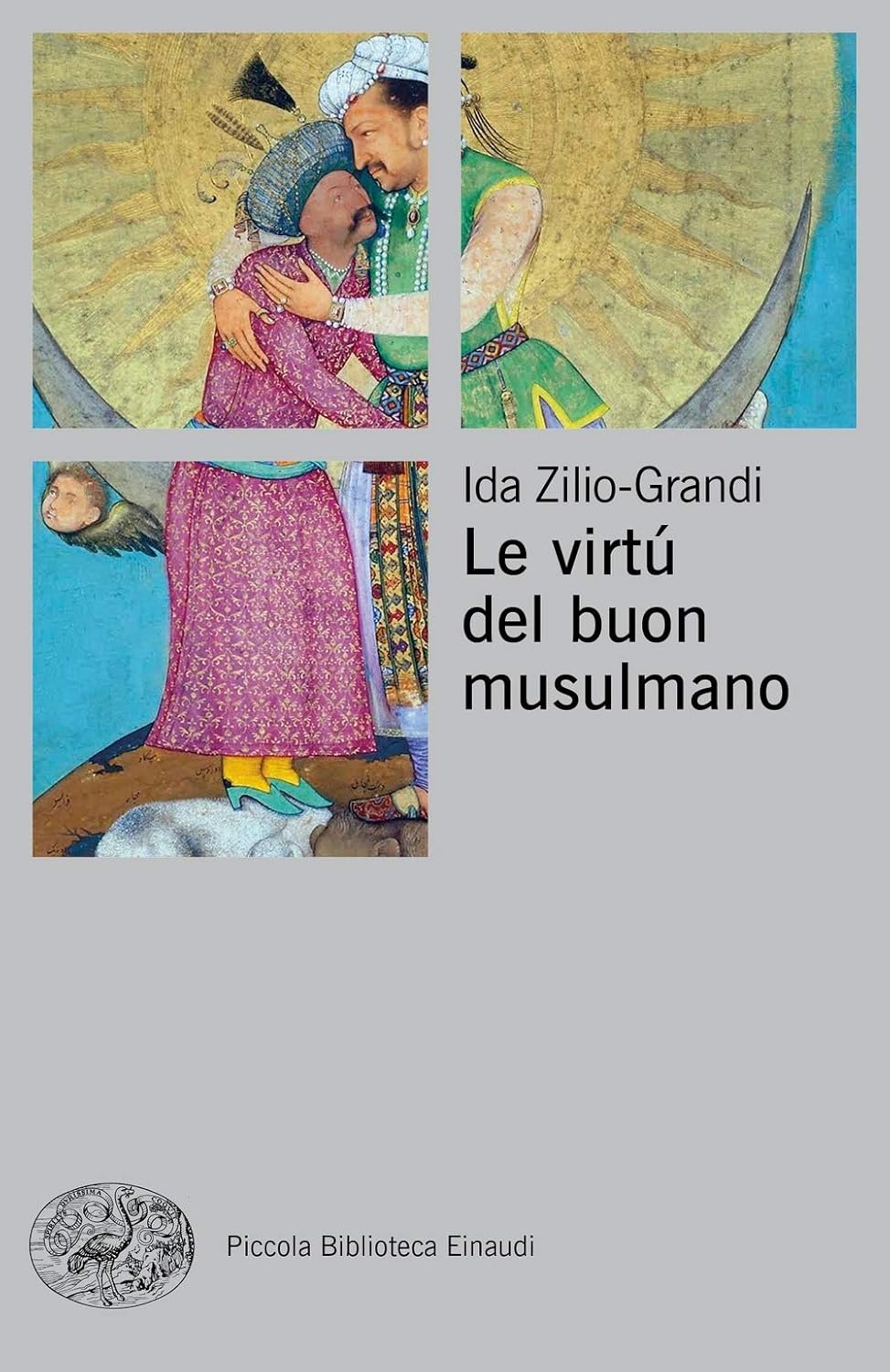






Commento all'articolo