La grande guerra nel Medio Oriente: La caduta degli ottomani 1914 / 1920 – Eugene Rogan
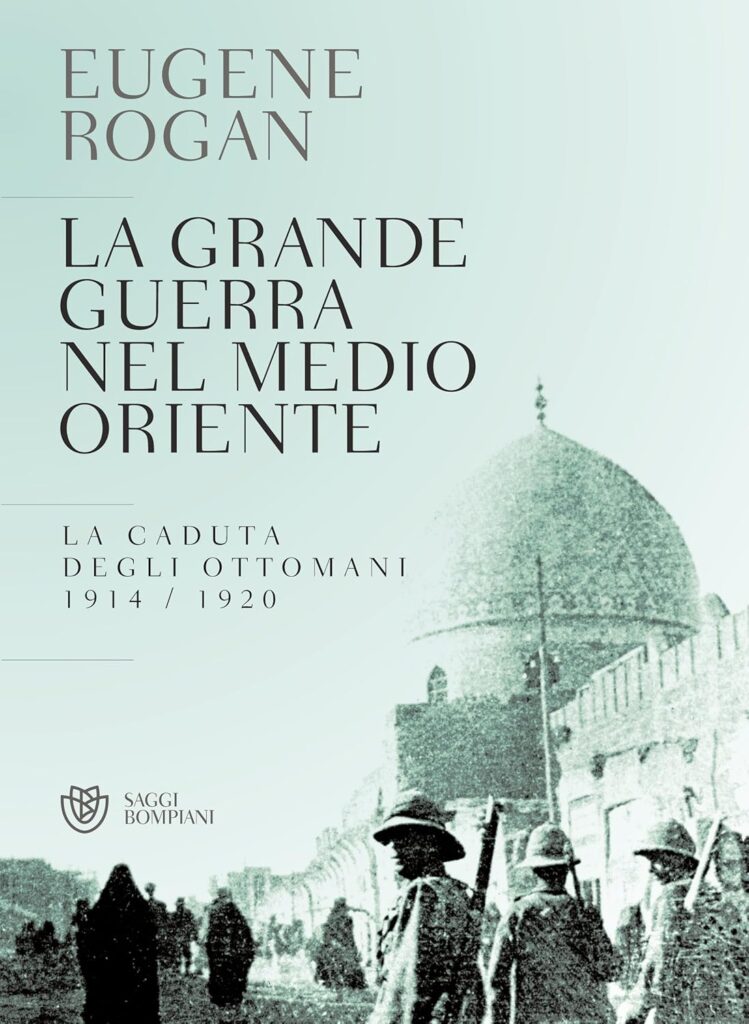
SINTESI DEL LIBRO:
Fra il 1908 e il 1913 l’Impero ottomano si trovò ad affrontare gravi minacce
interne ed esterne. A partire dalla rivoluzione dei Giovani turchi nel 1908, le
istituzioni politiche del vecchio impero arrivarono a un grado di tensione
senza precedenti. I riformatori cercavano di adeguare l’impero per portarlo
nel XX secolo. Le potenze imperiali europee e i nascenti stati balcanici
avevano mire espansionistiche sui territori ottomani. Attivisti armeni e arabi
cercavano di ottenere una maggiore autonomia dall’indebolito stato turco.
Queste problematiche, che dominarono l’agenda del governo ottomano negli
anni precedenti al 1914, fissarono i presupposti per la Grande guerra degli
ottomani.
Il 23 luglio 1908 l’attempato sultano Abdülhamid II convocò il gabinetto
di crisi. Il dispotico monarca doveva affrontare la più grave minaccia che si
fosse mai presentata nei tre decenni del suo regno. L’esercito ottomano in
Macedonia – l’instabile regione balcanica a cavallo degli attuali stati di
Grecia, Bulgaria e Macedonia – si era ribellato, chiedendo che fosse
restaurata la costituzione del 1876 e che si ritornasse a un regime
parlamentare. Il sultano conosceva i contenuti della costituzione meglio dei
suoi oppositori. Quando nel 1876 era salito al trono, uno dei primi
provvedimenti era stato proprio quello di promulgare la costituzione, a
coronamento di quarant’anni di riforme – note come Tanzimat – condotte dal
governo. Il sultano, a quei tempi, era visto come un riformatore illuminato.
Ma l’esperienza di governo aveva pian piano trasformato Abdülhamid in un
despota.
Le radici del suo assolutismo possono essere fatte risalire a una serie di
crisi che il giovane sultano si trovò fin da subito ad affrontare. L’impero che
aveva ereditato, infatti, si trovava in pieno caos. Nel 1875 il ministero del
tesoro aveva dichiarato bancarotta e i creditori europei non avevano perso
tempo a imporre sanzioni economiche. Inoltre gli ottomani, a partire dal
1876, incontravano una crescente ostilità da parte dell’opinione pubblica
europea a causa della violenta repressione operata contro i separatisti
bulgari, etichettata dalla stampa occidentale come “orrori bulgari”. A
guidare la severa condanna di questo comportamento fu il leader liberale
britannico William Gladstone. Nel frattempo la guerra con la Russia si
faceva sempre più vicina. L’esplosiva situazione presentò presto il conto ai
governanti. Un influente gruppo di ufficiali riformisti depose il sultano
Abdülaziz (1861-76) il quale, dopo neanche una settimana, venne trovato
morto con le vene dei polsi tagliate. Il suo successore, Murat V, ebbe un
crollo nervoso dopo soli tre mesi dall’insediamento. Questa era la
sconfortante situazione quando il 31 agosto 1876 il trentatreenne
Abdülhamid II salì al trono.
Potenti ministri del governo fecero pressioni affinché il sultano
introducesse una costituzione liberale e un parlamento elettivo con membri
musulmani, cristiani ed ebrei, per impedire ulteriori intromissioni negli affari
ottomani da parte dell’Europa. Abdülhamid accondiscese alle richieste dei
riformisti, più per senso di pragmatismo che per convinzione. Il 23 dicembre
1876 promulgò la costituzione ottomana e il 19 marzo 1877 inaugurò la
prima sessione del parlamento elettivo. Purtroppo, non appena insediato il
parlamento, l’impero si trovò coinvolto in una devastante guerra con la
Russia.
L’impero russo si considerava il successore di Bisanzio e il vertice
spirituale della Chiesa ortodossa orientale. Anche la Russia aveva mire
espansionistiche, in particolare nei confronti di Istanbul, che fino al 1453 era
stata centro della cristianità ortodossa e capitale bizantina. Non erano
semplici ambizioni culturali. Se fossero arrivati a possedere la capitale
ottomana, i russi avrebbero controllato gli strategici stretti del Bosforo e dei
Dardanelli riuscendo a collegare il mar Nero russo col Mediterraneo. Nel
corso del XIX secolo, però, gli stati europei confinanti della Russia avevano
ritenuto opportuno confinare la flotta dello zar nell’ambito del mar Nero
favorendo il mantenimento dell’integrità territoriale dell’Impero ottomano.
Frustrati nelle loro aspirazioni espansionistiche, i russi sfruttarono i
movimenti d’indipendenza nella regione balcanica per interferire negli affari
interni ottomani, avanzando nel frattempo pretese territoriali attraverso
reiterate guerre con l’Impero turco. Alla fine del 1876, tumulti scoppiati in
Serbia e Bulgaria costituirono un pretesto per un’ulteriore guerra
espansionistica. Nell’aprile 1877 – dopo essersi assicurata la neutralità da
parte dell’Austria e il permesso della Romania di poter attraversare il suo
territorio – la Russia dichiarò guerra agli ottomani.
Le forze dello zar avanzarono rapidamente all’interno del territorio
nemico nei Balcani, e, attraverso il Caucaso, nell’Anatolia orientale,
massacrando contadini turchi e musulmani via via che procedevano
nell’assalto sui due fronti. L’attacco russo provocò una pubblica
indignazione in tutti i domini ottomani. Il sultano Abdülhamid II fece leva
sulla propria eredità culturale islamica per assicurarsi l’appoggio del popolo.
Prese lo stendardo del profeta Maometto, che era in possesso degli ottomani
fin dal XVI secolo – quando l’impero aveva occupato le terre arabe – e
proclamò la jihad, la guerra santa, contro la Russia. Il popolo accorse al
richiamo del proprio sultano-guerriero contribuendo economicamente allo
sforzo bellico. Molti, inoltre, si offrirono come volontari, tanto che l’esercito
riuscì a bloccare l’avanzata dei russi.
Eppure, mentre Abdülhamid andava acquisendo sostegno, membri del
parlamento diventavano sempre più critici riguardo ai modi in cui il governo
gestiva il conflitto. Verso la fine del 1877, a dispetto della jihad, i russi
ripresero ad avanzare costantemente e nel gennaio 1878 giunsero alla
periferia di Istanbul. Un mese più tardi il sultano convocò una riunione per
consultarsi con i parlamentari sulla condotta da tenere. Uno di loro, a capo
della corporazione dei fornai, protestò: “Hai chiesto la nostra opinione
troppo tardi; avresti dovuto consultarci quando era ancora possibile evitare il
disastro. La camera declina ogni responsabilità per questa situazione con la
quale non ha niente a che fare.” L’intervento dovette convincere il sultano
che il parlamento era più di intralcio che di aiuto. Il giorno seguente
Abdülhamid sospese la costituzione, sciolse il parlamento e mise agli arresti
domiciliari alcuni tra i parlamentari più critici. Quindi cominciò a esercitare
un controllo diretto sugli affari di stato. A quel punto, però, la situazione
bellica era irrecuperabile e nel gennaio del 1878 il giovane sultano dovette
accettare un armistizio con l’esercito russo che si trovava alle porte della
capitale.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
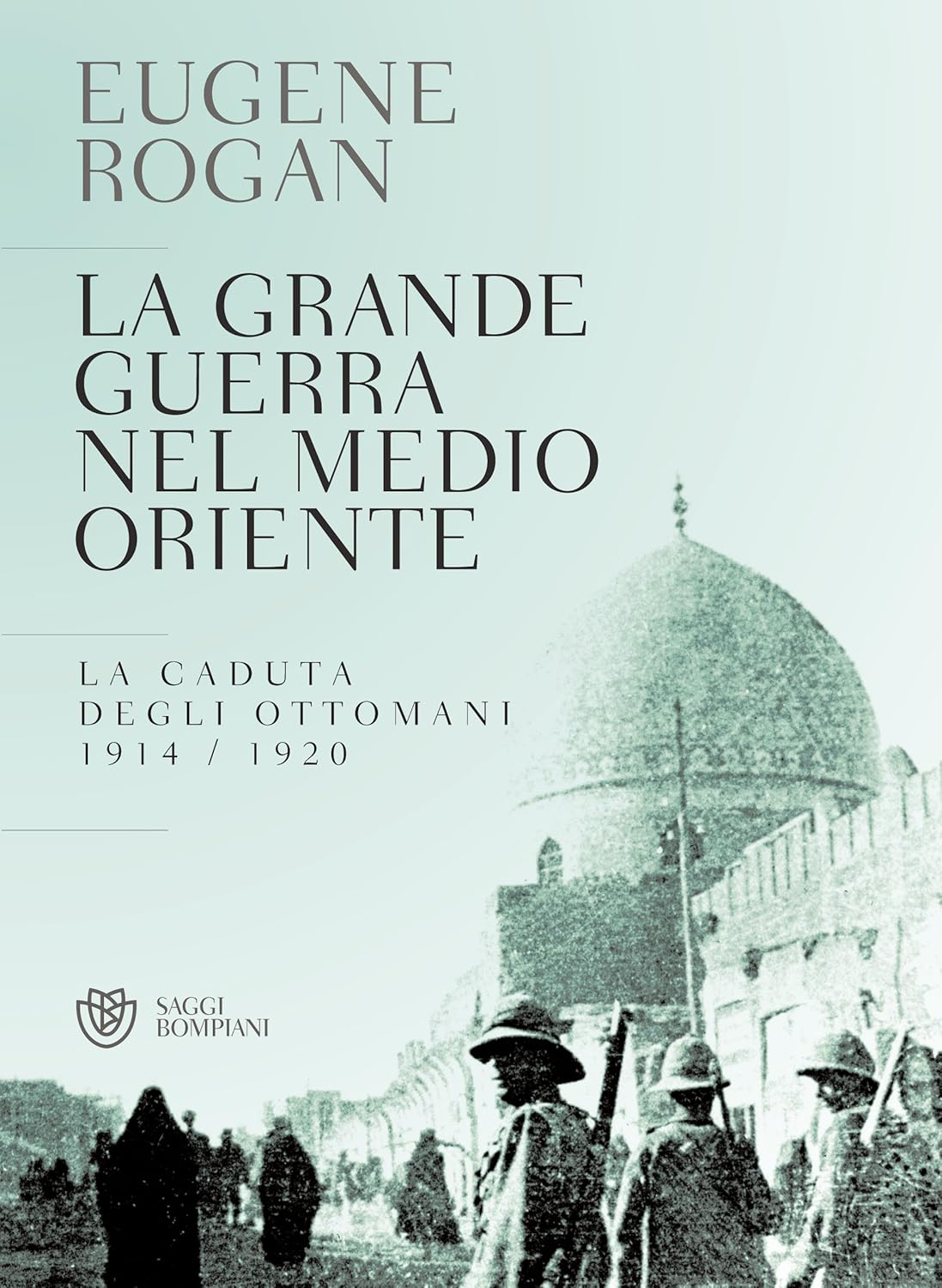






Commento all'articolo