Tutti gli uomini sono mortali – Simone de Beauvoir
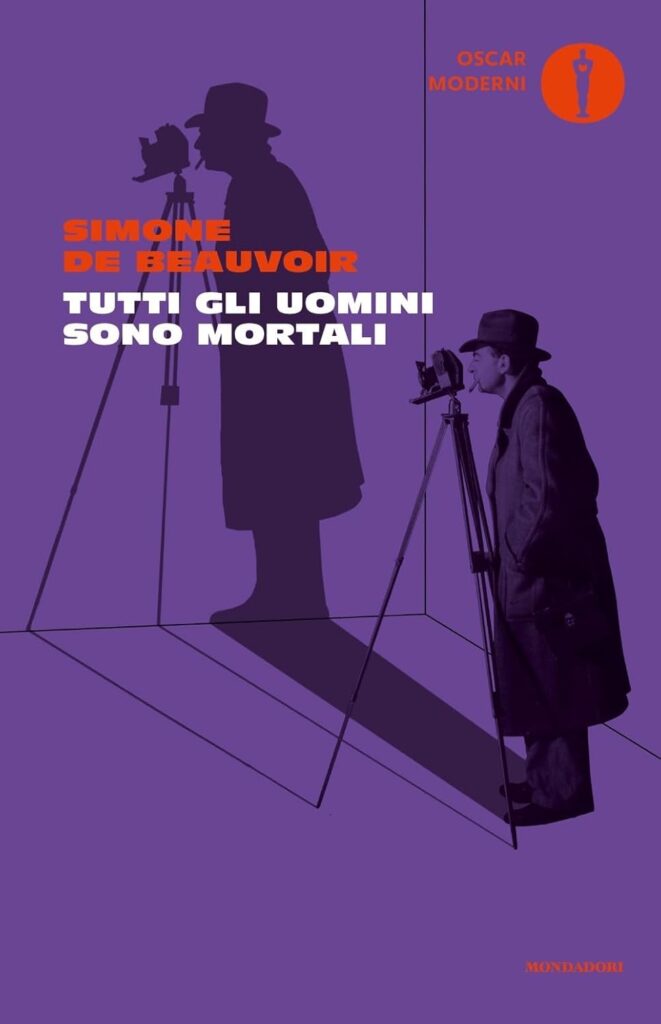
SINTESI DEL LIBRO:
Nel '43-44 mi sentivo nel flusso della Storia, ed è su questo
piano che intendevo muovermi. Non contento di conoscere la
fortuna e la gloria, il mio eroe avrebbe chiesto di influire sulle
vicende del mondo. Così mi venne l'idea di renderlo mmortale… Il
tema che ricorre forse con eccessiva ostinazione in tutto il libro è il
conflitto dei due punti di vista: quello della morte, dell'assoluto,
della stella più lontana, con quello della vita dell'individuo, della
terra; già a vent'anni, nei miei diari oscillavo da uno all'altro…» Così
scrive Simone de Beauvoir a proposito del suo terzo romanzo, nato
in piena guerra e pubblicato nel 1947, nel periodo di maggior
risonanza della cultura francese in Europa. Tutti gli uomini sono
mortali, dedicato non a caso a Jean–Paul Sartre, è forse la punta
estrema, il tentativo più ambizioso del romanzo esistenzialista.
Simone de Beauvoir (1908-1986), scrittrice e filosofa francese, ha
rielaborato i temi dell'esistenzialismo sartriano alla luce della
questione femminile. Tra le sue opere si ricordano i saggi Per una
morale dell'ambiguità (1947), La terza età (1970); i romanzi Il sangue
degli altri (1944), I mandarini (1954) e i volumi dell'autobiografia
Memorie di una ragazza perbene (1958), La forza dell'età (1960), La
forza delle cose (1963) e A conti fatti (1971).
Introduzione
Fosca nasce nella fantastica Carmona, in Italia, nel 1279. È duca della
città. Un giorno un vecchio mendicante gli offre in cambio della vita
un prezioso ma terribile regalo: l'elisir che rende immortali. Fosca è
avido, vuole la gloria, la conoscenza e il potere. Beve l'elisir e diventa
egli stesso Storia: del suo paese, dell'Europa e magari del mondo. Il
suo potere non ha più limiti ma in realtà, nel tempo umano, ogni sua
impresa vede il fallimento, le epoche si susseguono, qualunque
esperienza si ripete. Sangue e distruzione vengono incontro ai suoi
passi.
Fosca è l'unico uomo al mondo che ha vissuto e determinato il
potere di Carlo V, che ha perseguitato Lutero, che ha visto in Francia
l'epoca dei lumi, la Comune e così via. Ogni figlio muore.
Gli amori si spengono o diventano impossibili. La morte e i secoli
stendono veli sulla sua memoria, mescolano eventi. Da gran tempo
gli entusiasmi hanno visto la loro fine. Tutte le imprese che gli
uomini hanno compiuto per migliorare il proprio destino hanno
rivelato un'altra faccia di miseria, violenza, inutilità. Gli uomini
avanzano nel loro tempo umano come ciechi e irragionevoli insetti. E
nell'Assoluto niente è utile, niente è valido, niente vale la pena di
essere intrapreso. Anche l'amore è un finto miraggio perché la morte
lo interrompe e lo cancella. Solo la vita germoglia dalla vita in un
muto proliferare che niente distrugge. Il principio assoluto
dell'universo è lo spettacolo eterno della morte. È la pura essenza del
nulla, estranea all'uomo al quale tocca, come prezioso ma unico
bene, il presente.
Qui, nel presente, il romanzo inizia quando Fosca incontra
Régine, attrice ambiziosissima che vuole vincere la sua gara con
l'esistenza. Quando Fosca le rivela il proprio segreto, la sua
ambizione diventa follia: segnata nella memoria di lui, da lui amata,
entrerebbe nell'eternità e insieme costringerebbe Fosca in un limite,
vincerebbe la sua partita con il tempo. Sarà Régine, naturalmente, a
perdere. Il racconto di Fosca, che parte dal lontano 1279, ed è il vero
romanzo, si chiude con il distacco da Régine. Questi i fatti.
«Quando nel 1943 cominciai Tutti gli uomini sono mortali
pensavo a questo libro come a un lungo vagabondaggio intorno alla
morte…
Nel '43-44 mi sentivo nel flusso della Storia, ed è su questo piano
che intendevo muovermi. Non contento di conoscere la fortuna e la
gloria il mio eroe avrebbe chiesto di influire sulle vicende del
mondo. Così mi venne l'idea di renderlo immortale».
Il terzo romanzo di Simone de Beauvoir nasce in piena guerra.
Lo finirà e lo pubblicherà a guerra finita, nel 1947, anno in cui
esce anche Per una morale dell'ambiguità, contributo in margine alla
mastodontica impresa di Sartre, coagulata nell'Essere e il Nulla, ma
singolarmente vivo, come catechismo e vademecum del pensiero
esistenzialista, mentre l'opera di Sartre ne è la Bibbia. Erano gli anni
di maggiore risonanza della cultura francese in Europa.
I riferimenti e le date quindi non sono marginali e di comodo; ci
avvicinano a questo romanzo che mostra il suo scheletro di
dinosauro abbandonato, uscito dal nostro fisiologico sviluppo, e che
rientra come un reperto in scala gigante per le sue ambiziose arcate
strutturali dove risuonano sepolcrali lontananze. È un reperto che
chiama a raccolta altri nomi: Sartre, prima di tutto, Nizan, Camus;
Malraux; di sfondo André Gide e persino Simone Weil che, in
diversità generazionale e di cultura, tendevano però a usare la
propria vita quale corpo sperimentale del loro pensiero.
Non è un gruppo, è piuttosto una costellazione che tra gli anni
Trenta e Quaranta crea in Francia un sistema che si muove spinto da
un ordine di empatie oltre che di amicizie, in qualche modo vivendo
di reciproca luce, ritrovandosi in relative correlazioni ideologiche.
Semplificando al massimo: questi scrittori chiedevano all'esistenza
umana di dimostrare le proprie ragioni o significare l'assurdo del
suo stesso passaggio. In fondo, chiedevano al moto di fermarsi in
una pausa che permettesse di accenarne il senso, prima di riprendere
in eterno la fatale casualità. È il momento in cui la cultura laica,
manifestandosi clamorosamente nel suo diritto e nella sua forza, ha
insieme manifestato in quella richiesta paradossale la sua possibilità
di disperazione.
Simone de Beauvoir nel 1947 aveva già pubblicato due romanzi,
due successi: L'invitata e Il sangue degli altri, ma su questo terzo
romanzo aveva appuntato sforzi e speranze. Ci racconta, sempre
nell'autobiografia, che molto probabilmente Queneau aveva
proposto a Gallimard una tiratura di 75.000 copie, cifra incredibile
per quegli anni, e che lei era davvero convinta di aver fatto il suo
migliore lavoro. Però Tutti gli uomini sono mortali è un insuccesso.
Molti critici già benevoli l'abbandonano. Ne deriva quasi una
condanna. Leiris osservò un poco malignamente che faceva del
fantastico un uso troppo ragionevole. Insomma Simone de Beauvoir
riconosce con realismo e senso pratico che era stata una sconfitta, che
qualche cosa non aveva funzionato nella sua valutazione del
romanzo e del rapporto che il romanzo avrebbe avuto con i lettori e i
critici. C'era stato un errore, ma quale?
Si può rileggere Tutti gli uomini sono mortali come la ricerca di
questo errore. Sarebbe presto detto, in fondo: i contenuti fantastici
non sono restituiti a una credibilità poetica, non si genera un mondo
che ha in sé un suo senso, i personaggi non palpitano sotto le grandi
arcate, tutto è affidato al convincimento di una narrazione
abilissima, di un dettato fluido, e alla stimolante impresa di una
inventiva raziocinante. Però sarebbe un'archiviazione ingiusta e
riduttiva.
Prima di tutto, per valutare e capire l'impegno fuori scala in cui si
cimentò la scrittrice, si deve tener presente il carico dimostrativo che
si portava dietro, ormai da anni, il romanzo francese e dal quale
pareva non voler emergere. Così mentre irradiava la sua luce a
distanza, nel successo europeo, all'interno si dibatteva in
drammatiche contraddizioni.
Una di queste contraddizioni è davanti ai nostri occhi. La
dimostrazione romanzata contro gli Assoluti cade per autogol: pecca
di astratta ideologia e perde di vista l'uomo che vuole difendere. Un
protagonista immortale esula dal romanzo esistenziale per forza di
contraddizione. Potrebbe reggere se l'iterazione delle sue esperienze
apparisse picaresca o surreale; e infatti il surrealista Leiris aveva
visto giusto: non si può rendere ragionevole il fantastico, cioè: non si
può rendere esistenziale l'immortalità.
La stessa de Beauvoir ci avvisa che Fosca è un'allegoria. Ed è
un'allegoria nata dalla polemica sartriana condotta verso il mondo
cattolico, e marxista. Non a caso, infatti, il romanzo è dedicato a
Jean–Paul Sartre. Se è un errore concepire un romanzo come
un'allegoria, è un errore generazionale dunque. Infatti l'aver vissuto
la propria vita di uomini solo come la proiezione di un impegno, si
ribaltò nel romanzo pecché il romanzo assorbe il modo di essere del
tempo e ciò che nel tempo l'uomo è; si fa prisma e ci riverbera la
nostra storia intellettuale; è il documento antropologico più
sensibile, più impressionato nelle sue lastre fantastiche da dolori,
pensieri, situazioni civili e convinzioni politiche. Ci serve "anche" per
fare storia, entrare in una realtà che non c'è più, e capire la nostra
attraverso l'uso che lo scrittore fa della sua Fantasia e del suo stile.
Così Tutti gli uomini sono mortali ci costringe a riflettere su un
tema che pare diventato dagherrotipo culturale: i fini e le ragioni del
romanzo contemporaneo. Qui, per esempio, Proust, Svevo o Joyce
non c'entrano. Siamo nell'epicentro del fenomeno opposto che si
classifica come romanzo impegnato, portatore esso stesso, cosciente,
di un valore o disvalore etico–politicoSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
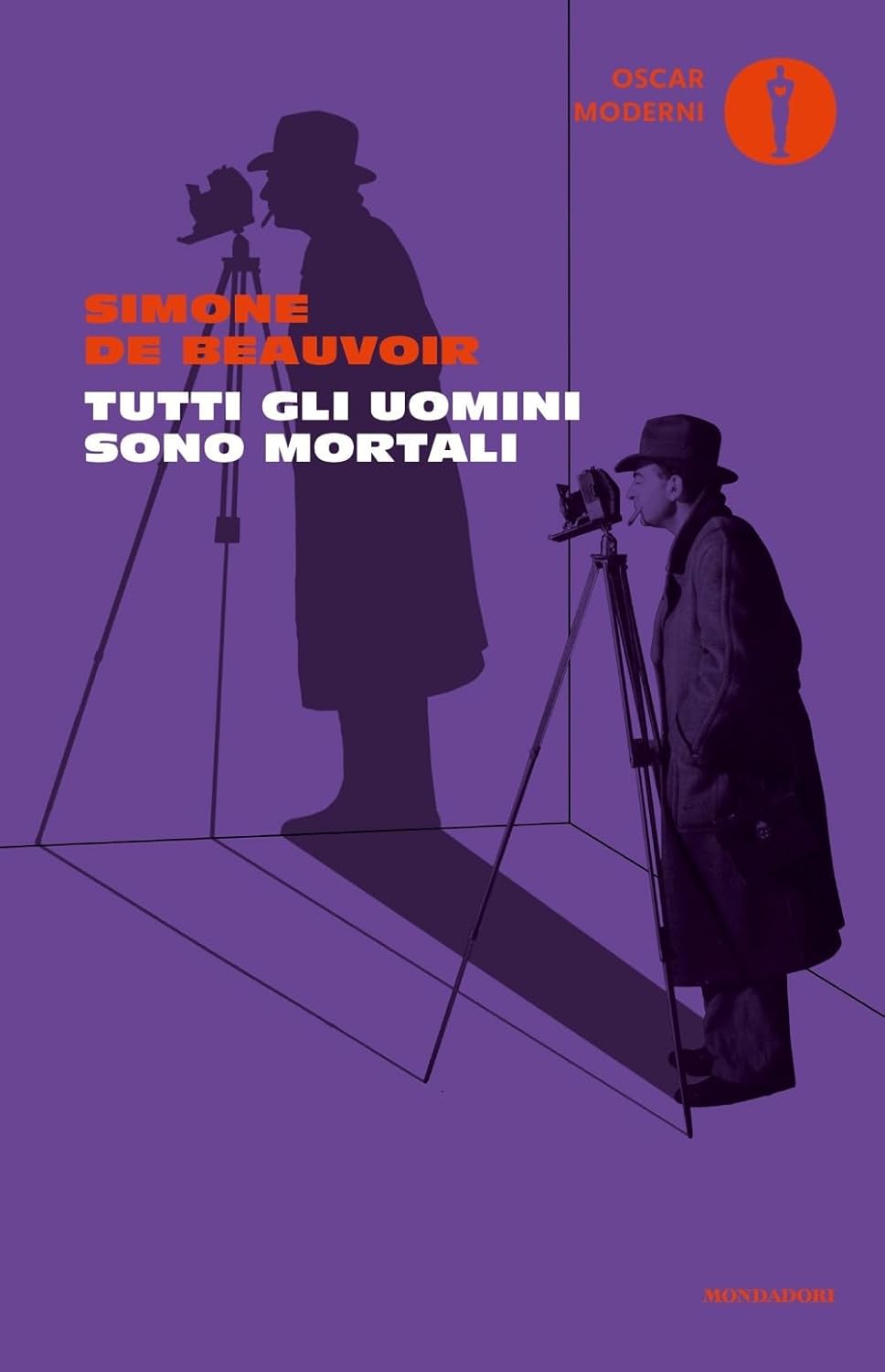



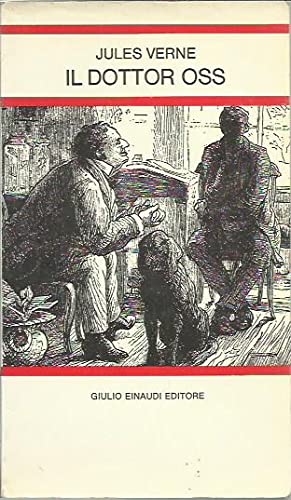
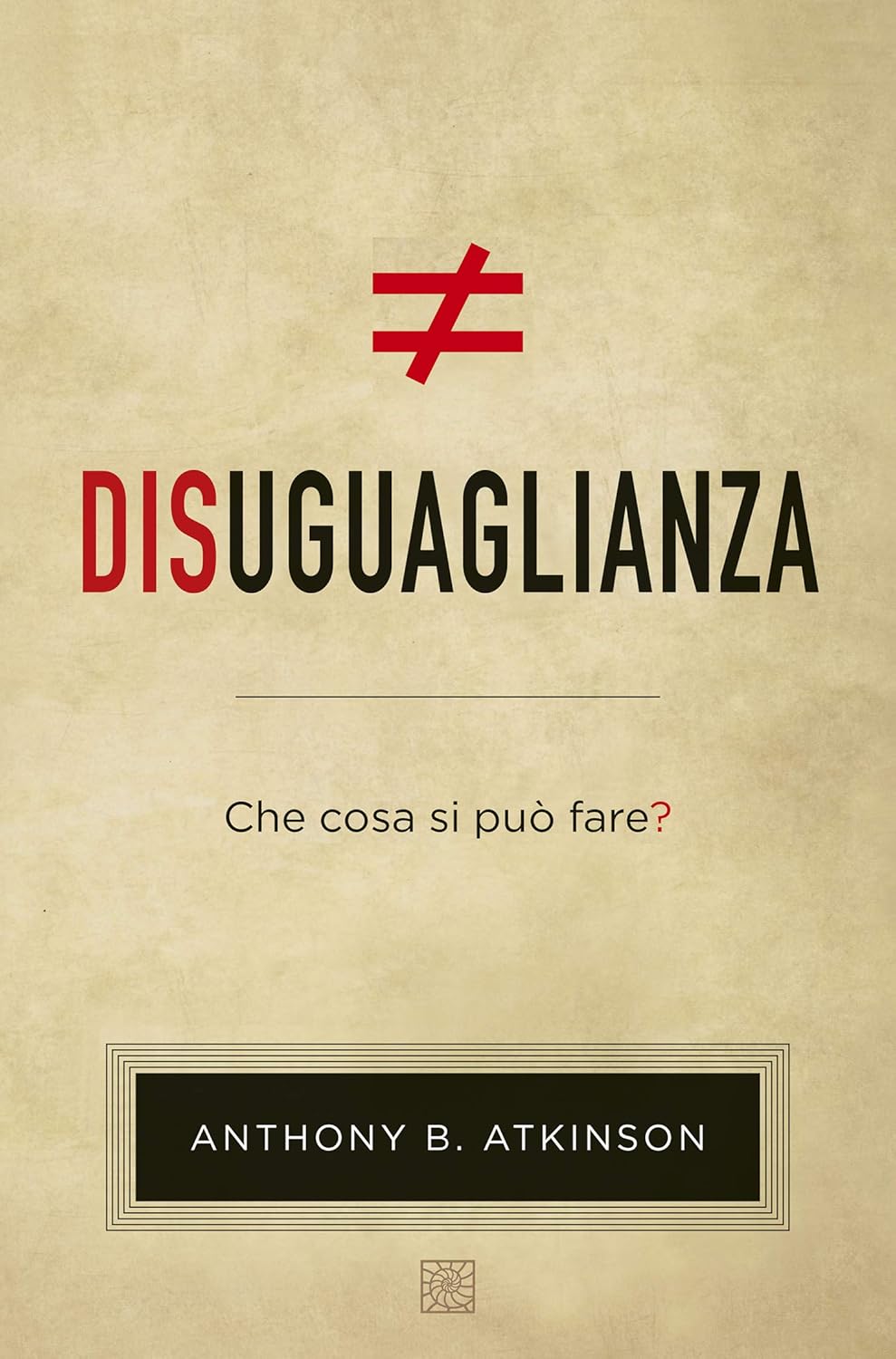
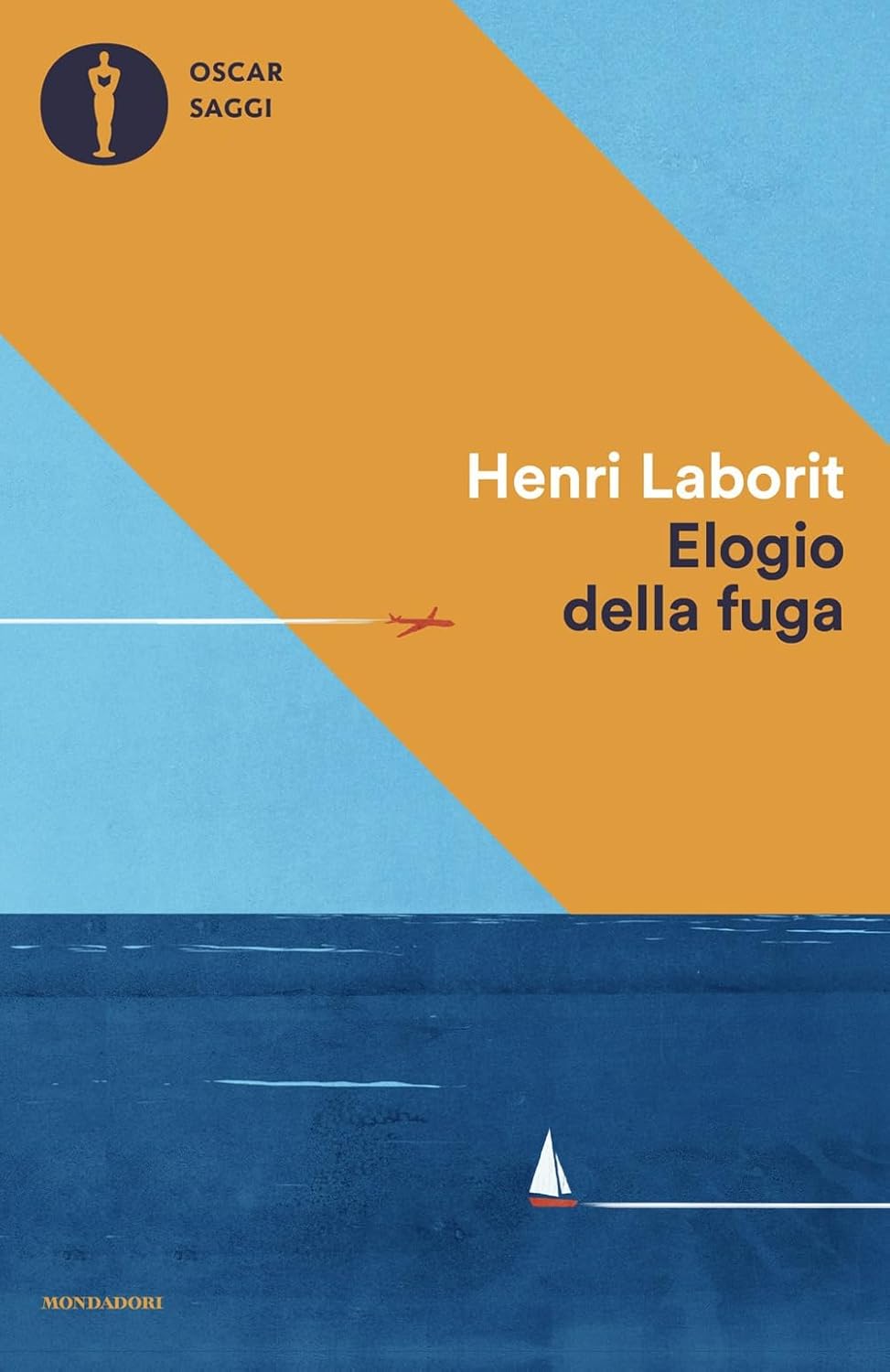
Commento all'articolo